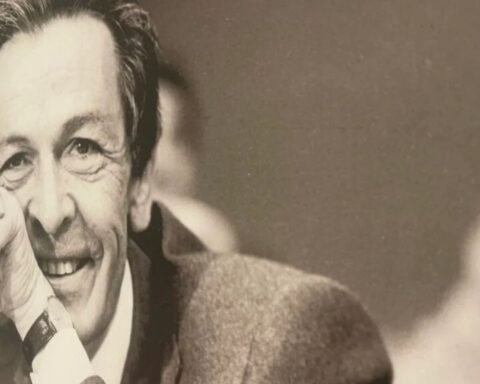La domanda «vogliamo l’uomo forte al comando?» riecheggia puntualmente come un interrogativo provocatorio, ma incredibilmente rilevante, soprattutto in un’epoca in cui la politica globale sembra oscillare tra il desiderio di stabilità e l’aspirazione alla libertà. Nell’ultimo secolo, la storia ha fornito numerosi esempi di leader carismatici e autoritari che, con il loro potere decisionale e la loro personalità dominante, hanno promesso ordine e prosperità in tempi di crisi, spesso, però, scrivendo alcune delle pagine più drammatiche della nostra storia recente.
Nonostante l’innegabile prezzo alto che abbiamo pagato per esserci affidati all’uomo che con il pugno di ferro promette di migliorare la vita di chi lo sostiene, per una fetta della popolazione ancora oggi quella continua a essere una via percorribile, per alcuni da provare, per altri a cui aspirare. La domanda continua così a insediarsi forse più che nel singolo nella collettività, come fosse una condivisa ricetta segreta di salvezza, un’eco lontana, un “sentito dire” non sperimentato che si insidia anche nelle democrazie più solide. Una sorta di inconscio collettivo, per dirla con le parole del famoso psicoanalista Carl Gustav Jung che ne ha sviluppato il concetto, secondo cui di una parte della psiche umana che non è influenzata dalle esperienze personali, ma è comune a tutta l’umanità. La retorica, i media, la propaganda fanno il resto. Impossibile, in tempi come i nostri e nell’anno record di voto popolare, non domandarci quanto questa domanda influenzi le fragili democrazie occidentali.