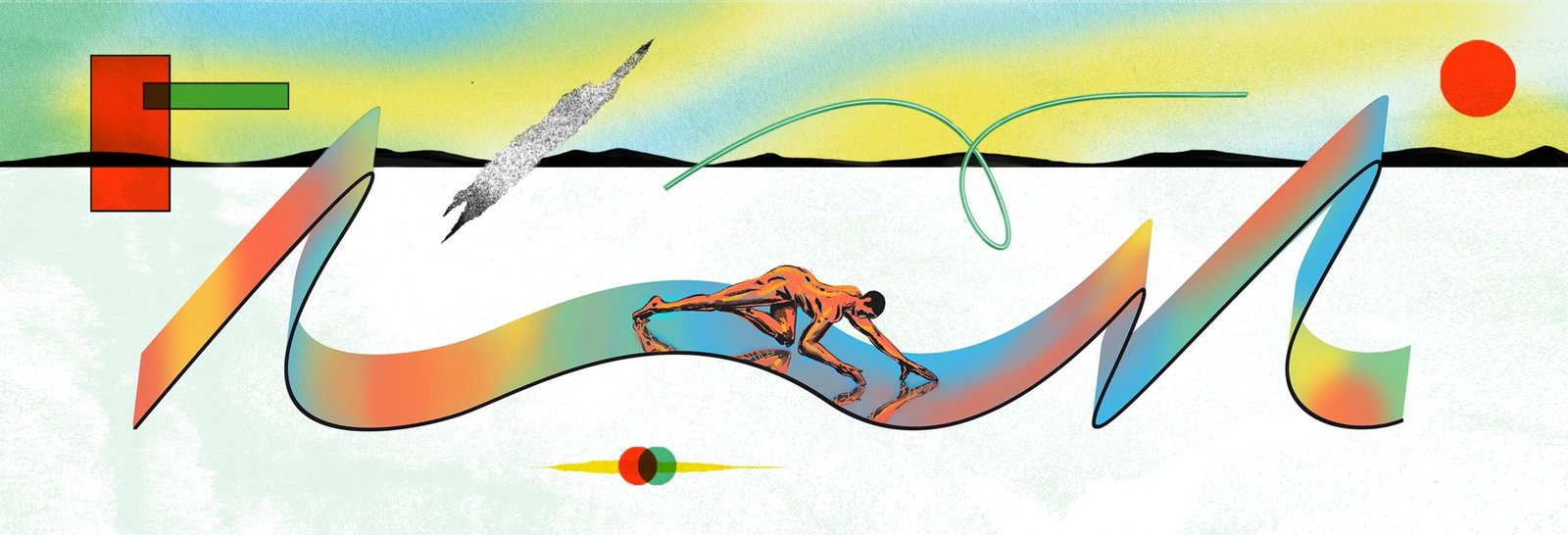Cosa accadrebbe
se eliminassimo la profondità?
La tradizione filosofica ci ha abituati a ritenere che la verità delle cose, la loro realtà più reale, concreta, sicura, si nasconda dietro l’involucro superficiale che la tiene nascosta dall’esterno. È nel profondo, si dice, che bisogna guardare per rintracciare la verità – la verità di un volto (un “bel” volto), di un gesto (un “buon” gesto), di un significato (un significato “autentico”). La filosofia stessa, d’altronde, nasce accompagnata da quest’idea, che cioè l’essenza di ciò che conosciamo debba scavalcare l’apparenza per mezzo della quale esso si rivela. È Socrate, ricordiamocelo, colui che ha inaugurato questo paradigma di pensiero. Socrate, figlio di una civiltà che stava imparando a scrivere distaccandosi dal mondo dell’oralità e del mito che l’aveva preceduta, non vuole che ai suoi interrogativi si risponda con esempi (“coraggioso è questo guerriero, questa madre, questo animale – non vedi, Socrate?”); Socrate pretende che la cosa sia circoscritta, definita, che il suo perimetro – tracciabile dall’intelletto – ne scalzi il darsi superficiale per lasciare emergere quella roccia dura attraverso cui, essa, la cosa, possa mostrarsi nella sua verità. Fu mandato a morte. Peggio, direbbe Nietzsche; con Socrate ebbe inizio la decadenza della civiltà occidentale, la fine di questa straordinaria avventura, piena di genio ma insieme piena di sangue che siamo noi.
Leggi anche:
Sulla solitudine
I manuali di storia della filosofia ci hanno insegnato che la domanda con la quale Socrate scalzava la certezza dei suoi interlocutori, da lì in poi divenuta il sancta sanctorum del pensiero occidentale, è tanto semplice quanto tremenda: che cos’è? Che cos’è il bello?, il buono?, la virtù? chiedeva Socrate. L’apparire della cosa trova il suo ostacolo più grande nel questionario socratico: l’esperienza, attraverso di esso, è ridotta a sapere manchevole. Ciò che si dà alla vista, ciò che l’occhio può indicare, insomma, la superficie delle cose è solo il prodromo di un’intuizione più alta, che si coglie non attraverso il corpo, ma per mezzo della visione superiore dell’intelletto. Allora, ad esempio, l’amore non può e non deve essere amore per il corpo, poiché il corpo invecchia, come il fiore appassisce – e ciò che invecchia e appassisce non detiene alcun valore di verità, essendo irreale. Amore sarà amore dello spirito, o, come la tradizione cristiana ci ha suggerito, dell’anima, l’eterna presenza della persona dietro alla transeunte dimensione superficiale. Lo stesso vale per, altro esempio, il buono, poiché buona può essere sola l’intenzione dell’azione, ciò che la muove, kantianamente il fine che la sospinge, e non l’azione così come essa ci appare, così come noi vediamo essere buona una carezza, un bacio, un gesto d’affetto. Ugualmente dietro le parole, dietro il suono materiale – ciò che in filosofia si chiama significante – si nasconde l’autentico messaggio della parola, il significato, che permane al di là del mezzo che lo trasmette. Su questa certezza è potuta nascere la scienza, portatrice di un sapere che si apposta dietro la superficie dei fenomeni per coglierne in profondità le leggi matematiche, immutabili. Ma su questa certezza è nata anche l’idea che l’uomo stesso sia costituito di una doppia dimensione, di una doppia realtà, quella carnale e quella spirituale, quella esteriore, superficiale, e quella interiore, vera poiché profonda.
Leggi anche:
Sulla natura
Ora, cosa accadrebbe se volessimo sospendere il giudizio su questa visione del mondo che noi, bene o male, ci portiamo ancora dietro? Cosa accadrebbe se lasciassimo da parte il pregiudizio, perché, come Nietzsche sapeva bene, di pregiudizio si tratta, che postula un mondo dietro il mondo? Cosa accadrebbe, a livello filosofico, morale, etico, se eliminassimo la dimensione della profondità?
Accadrebbe questo: saremmo come proiettati in un mondo nel quale non esistono confini, o meglio, nel quale i confini delle cose, pur offrendosi alla vista, sono come le pieghe di una stessa superficie; saremmo proiettati in un mondo fatto più che di deduzione, di tatto e di vista, di colori e sensazioni, nel quale l’immediatezza si dipana quale vera e propria trama del reale, un ordito infinito che connette, come una rete senza capo, tutti gli esseri, tutti gli esistenti. Un mondo, in questo senso, ecologico, nel quale ogni punto è il nodo sul quale si allaccia una relazione, e ancora un’altra, e un’altra ancora. Un mondo del quale ogni vivente – giacché tutto, sulla superficie, è vivente, partecipando dello stesso piano di realtà – non può dirsi tale se non in connessione a tutti gli altri. Una superficie assoluta, che va dal vegetale, aristotelicamente misura dell’inerzia, all’umano, che della pianta, seguendo quest’ottica superficiale, non è lo sviluppo di una dimensione profonda (l’interiorità, l’intelligenza, ecc.), ma l’inversione simmetrica di uno schizzo del tutto a-geometrico, di un labirinto di forme che dal basso (la radice) si sposta in alto (il cervello).
Donando consistenza alla superficie, ci si rende conto che tutto vive, tutto sente, che la vita stessa, nel suo dispiegarsi tramite le infinite linee che la percorrono, è coscienza di sé, ossia apertura agli altri nodi della superficie. Quest’idea della monodimensionalità dell’esperienza e insieme del reale ha un nome filosofico (empirismo trascendentale) e può essere associata ad una grande figura del pensiero francese del ‘900, Gilles Deleuze. Secondo Deleuze la trama del reale è fatta di pieghe, come quelle che la vita – questa linea infinita – produce ritornando ogni volta su di sé; come quelle del rizoma, che per Deleuze rappresenta l’autentico metodo del filosofare, nel quale non vi è entrata né uscita, ma un ramificarsi esplosivo, dove ogni punto si traduce in connessioni infinite che permettono salti da un concetto all’altro, illegittimi agli occhi di un pensiero della profondità. Non vuole significare questo ritorno della superficie l’Impressionismo? In Monet sono le cose stesse che parlano donandosi alla nostra sensibilità sotto forma di impressioni, in un atto che è immediatezza e pura forza presentificatrice. Questo connubio di presenza e impressione, colora la dimensione della superficie sul quale le cose acquistano il loro significato autentico, quello della vita che le vede per la prima volta.
Leggi anche:
Sul corpo
La superficie, dunque, è la misura autentica dell’ecologia, di un pensiero che non guardi dall’alto ciò che conosce, ma che partecipi del suo divenire, inestricabilmente legato ad esso. Ludwig Wittgenstein sosteneva che è proprio l’illusione della profondità ad aver creato i mostri metafisici che ancora non riusciamo a toglierci di dosso, è proprio il domandare socratico ad averci indotto ad un fraintendimento durato millenni. Una metamorfosi continua, linee che s’intersecano, un’irradiarsi senza mediazione di ogni atto sul resto del reale. Non è il caso, oggi, di cambiare prospettiva, tentando la strada della superficie? In fondo, l’intuizione più profonda sembra suggerirci proprio questo, che, come scrisse una volta Karl Kraus, «le radici stanno in superficie».
In copertina: Artwork by Tatanka Journal
© Riproduzione riservata
Segui Frammenti Rivista anche su Facebook, Instagram e Spotify, e iscriviti alla nostra Newsletter
Sì, lo sappiamo. Te lo chiedono già tutti. Però è vero: anche se tu lo leggi gratis, fare un giornale online ha dei costi. Frammenti Rivista è edita da una piccola associazione culturale no profit, Il fascino degli intellettuali. Non abbiamo grandi editori alle spalle. Non abbiamo pubblicità. Per questo te lo chiediamo: se ti piace quello che facciamo, puoi iscriverti al FR Club o sostenerci con una donazione. Libera, a tua scelta. Anche solo 1 euro per noi è molto importante, per poter continuare a essere indipendenti, con la sola forza dei nostri lettori alle spalle.