La Natura
esiste davvero?
Sembra facile distinguere la natura per riflesso dalla cultura. L’intervento dell’uomo sancirebbe, secondo quest’ottica condivisa, il confine fra il naturale e l’artificiale (o il culturale), così che, là dove egli non abbia messo mano, là dove egli non sia intervenuto, proprio lì troveremmo ciò che la natura ci offre. Un albero, per logica conseguenza, è natura, il mare è natura, la montagna, il cielo, ecc. ad libitum, sono natura. Spingendosi lungo questa direzione, si possono elaborare tante idee diverse di ciò che è la natura quanti caratteri di essa noi vogliamo privilegiare. Così, la tradizione giudaico-cristiana ci ha consegnato l’idea sublime di una natura fatta per l’uomo, che egli deve popolare e coltivare; la grecità invece ci parla di una natura autonoma, la quale, come un organismo, cresce e si sviluppa in maniera autosufficiente, alimentandosi di se stessa; la modernità, ancora, ci ha insegnato che la natura, nella sua inerzia, detiene tanta più potenza quanta più noi, l’uomo, riusciamo a trarre da essa, giustificando qualsiasi azione violenta, o meglio, violentatrice che voglia appropriarsene; fino (ma si potrebbe proseguire) all’immagine, bellissima, di una natura indifferente, madre tremenda e insieme magnifica nel suo silenzio, che dell’uomo, scriveva Leopardi, semplicemente “non se ne avvede”.
Leggi anche:
Sulla Solitudine
Questi fili che s’intrecciano e che hanno consegnato alla contemporaneità l’idea di una natura priva di diritto, che risiede là dove l’uomo non ha ancora lasciato traccia, si complicano quanto guardiamo la cosa un po’ più da vicino. Chiediamoci, ad esempio: la foresta amazzonica è naturale? Così parrebbe, eppure sono molti gli studi etnobotanici che dimostrano che è stato il massiccio intervento umano a darle la configurazione che ora detiene. Una siepe, ancora, è natura? Eppure, è l’uomo ad averla edificata, dandole la forma, la costituzione che le permette di assolvere la sua funzione – separare il giardino della nostra abitazione da quello dei vicini. O, ancora, complicandoci la vita, un virus è natura o cultura? Un libro del quale si è tanto parlato proprio in questo periodo, Spillover di David Quammen si occupa del problema delle cosiddette zoonosi, ossia dei salti di specie, spesso nefasti, che permettono ai virus di trasmettersi da, mettiamo, un pipistrello ad un cavallo ad un uomo (come più o meno, pare, sia accaduto con il COVID-19). Ebbene, la tesi di Quammen (fatto, peraltro, risaputo) è che queste tipologie di mutazioni virali sono dovute (anche) alla sovversione di un sistema ecologico. All’interno di un ambiente nel quale un certo equilibrio ecologico si è assestato in un ciclo definito di interazioni, un elemento estraneo viene introdotto dall’esterno (di solito, un animale portato in un ambiente non suo proprio dall’uomo). Il meccanismo, che si era mantenuto in equilibrio, salta, facendo germinare i virus rimasti latenti. Allora il virus parrebbe naturale, però è qualcosa di artificiale, il più delle volte umano, ad averlo causato. Come la mettiamo?
Heidegger diceva che se togliamo il concetto di natura dall’edificio della civiltà occidentale, ne crollano le basi. Aveva ragione. Tutto ciò è complicato dal fatto che il nostro modo di concepire le cose, come per una specie di imprinting educativo-cognitivo, dicotomizza il reale nei regni distinti di naturale e culturale. L’Università stessa, inoltre, ci insegna che esistono due grandi campi del sapere, le scienze della natura (la fisica, la matematica, la biologia, che si occupano, per l’appunto, della natura) e le scienze della cultura (la psicologia, la pedagogia, la sociologia, l’antropologia ecc.) che si occupano, più generalmente, di ciò che ha a che vedere con l’uomo. Anche questa distinzione sancisce la separazione netta di due domini, quello dell’intemporale, dello stabile, dell’autonomo (la natura) e quella del “sociale”; là dove è l’uomo, per eccellenza, l’animale che partecipa della socialità.
Leggi anche:
Sulla Libertà
Spostiamoci nel Sud America. Numerosi studi antropologici hanno mostrato che all’interno delle popolazioni che abitano l’area del bacino amazzonico, grosso modo la fetta di terra che ricopre i territori al confine tra Ecuador e Perù, non esiste una vera e propria distinzione tra natura e cultura. O meglio, ciò che presso di noi, occidentali, è detto naturale, per loro, Indios, può chiamarsi culturale. Così, ad esempio, la foresta, luogo per eccellenza della selvatichezza, è la semplice estensione del giardino domestico, accudito con solerzia dalle donne dei villaggi Achuar; gli animali, specialmente quelli cacciati, sono “parenti” degli uomini, e intrattengono con questi ultimi un rapporto, si direbbe, di tipo sociale. C’è di più. Secondo queste popolazioni (ma il discorso vale anche per numerose altre aree insediative, della Siberia, dei territori a nord del Canada ecc.), ogni essere vivente (vegetale, animale, umano) è una “persona”, ossia condivide con tutti gli altri un fondo comune di spiritualità, un attributo universale che interseca orizzontalmente qualsiasi distinzione di specie. Così, l’albero è una persona, il giaguaro è una persona, l’uomo è una persona. Ma, chiederete, come facciamo a distinguere un albero da un giaguaro da un uomo se, tutti e tre, sono persone? Semplice, risponderebbe un Achuar: è il corpo che differenzia la visione che ognuno di noi getta sul mondo. È a partire dalla veste carnale che riveste il fondo – culturale – che tutti, umani e non, ci accomuna, l’essere persona, che diventa possibile gettare una prospettiva sul mondo diversa. Attenzione però. È scorretto dire, assecondando un’ottica tutta occidentale, che si tratti di “visioni del mondo” – quella dell’albero, del giaguaro, dell’uomo -, perché così si presupporrebbe che il mondo che essi guardano sia lo stesso, inquadrato da tre diversi punti di vista. È proprio questo il punto: i mondi sono tre, quello dell’albero, del giaguaro, dell’uomo, e ognuno di essi è irriducibile all’altro. Si tratta, per l’appunto, per mutuare la dicotomia natura/cultura, di tre nature diverse che si staccano da uno stesso fondo comune, l’essere persona.
La cosa interessante è che questi fatti non sono limitati al quadratino di terra verde che delimita le zone di insediamento Achuar. Intere popolazioni che abitano i territori a Nord del Canada, ma anche le tundre siberiane, pensano la natura allo stesso modo, ossia, sostanzialmente, non la pensano. Se si dice che il ghiacciaio “può ascoltare” le voci degli umani; che la foresta “domanda” un certo atteggiamento di rispetto verso di essa, parliamo di natura o di cultura? Evidentemente il binomio è mandato in cortocircuito da questi rilievi.
Leggi anche:
Sul Corpo
Si chiederà: a che fine? A che fine questo discorso? Si tratta di un sogno romantico, che si nutre della saggezza esotica strizzando l’occhio ad un certo primitivismo francamente demodé? Nient’affatto. Il punto è che la natura non esiste. Essa è un dispositivo concettuale creato dall’occidente, in una serie di scambi temporali di lunga durata, che ha portato più danni che benefici (anche se i benefici ci sono. Senza una certa idea di natura niente fisica classica, niente relatività, niente chimica, in poche parole, niente scienza, niente progresso… Ma questo è un beneficio o un danno?). E se muore la natura muore anche la cultura. Abbattiamo la foresta amazzonica. Pensavamo di aver abbattuto qualcosa di naturale, eppure le conseguenze nefaste le accusiamo noi, provenienti dalla cultura. Lasciamo che un ghiacciaio si sciolga. Credevamo di poterci ricavare soltanto buona energia idroelettrica, eppure la città che sorge poco più a valle risentirà enormemente dello sconvolgimento ecologico.
Allora, la domanda è questa: non val forse la pena di lasciar da parte un concetto così rousseauiano come quello di natura? Il quale ci accieca, a dir la verità, più che renderci lucidi. Perché finché continueremo a pensare che esiste qualcosa come “la natura” che se ne sta lì, immobile, silenziosa, pascendoci senza prestiti con i frutti del suo grembo, avremmo trascurato ciò che siamo veramente: una rete d’interazioni, il filamento di una treccia. Niente natura, niente cultura; solo umani e non-umani, sapendo che la circolarità tra i due poli del rapporto è necessitata. Agendo sull’uno s’influisce sull’altro senza scampo. Eppure, noi uomini della Ragione, abbiamo impiegato così tanto tempo per capire questa semplice verità, e forse non l’abbiamo ancora capita – verità che ben s’intuisce nelle parole, profonde e tremendamente chiaroveggenti, di Kopenawa, anziano sciamano yanomami:
«La foresta è viva. Può morire solo se i Bianchi si ostinano a distruggerla. Se ci riescono, i fiumi scompariranno sotto la terra, il suolo diventerà friabile, gli alberi rinsecchiranno e le pietre si spaccheranno per il calore. La terra inaridita diventerà vuota e silenziosa. Gli spiriti xapiri che scendevano dalle montagne per venire a giocare sui propri specchi fuggiranno lontano. I loro padri, gli sciamani, non potranno più chiamarli e farli danzare per proteggerci. Non saranno in grado di respingere i fumi d’epidemia che ci divorano. Non riusciranno più a contenere gli esseri malefici che faranno volgere al caos la foresta. Allora moriremo gli uni dopo gli altri e così anche i Bianchi. Tutti gli sciamani periranno. Quindi, se nessuno di loro sopravvive per trattenerlo, il cielo crollerà».
In copertina: Artwork by Tatanka Journal
© Riproduzione riservata
Segui Frammenti Rivista anche su Facebook, Instagram e Spotify, e iscriviti alla nostra Newsletter
Sì, lo sappiamo. Te lo chiedono già tutti. Però è vero: anche se tu lo leggi gratis, fare un giornale online ha dei costi. Frammenti Rivista è edita da una piccola associazione culturale no profit, Il fascino degli intellettuali. Non abbiamo grandi editori alle spalle. Non abbiamo pubblicità. Per questo te lo chiediamo: se ti piace quello che facciamo, puoi iscriverti al FR Club o sostenerci con una donazione. Libera, a tua scelta. Anche solo 1 euro per noi è molto importante, per poter continuare a essere indipendenti, con la sola forza dei nostri lettori alle spalle.



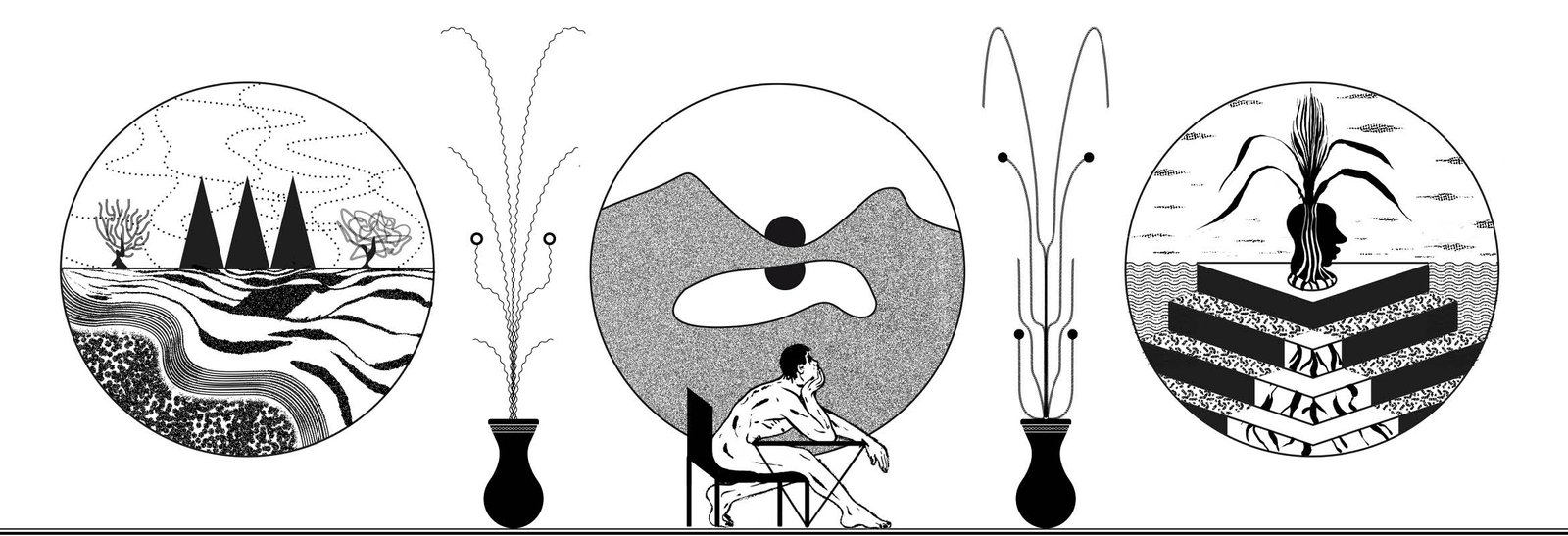



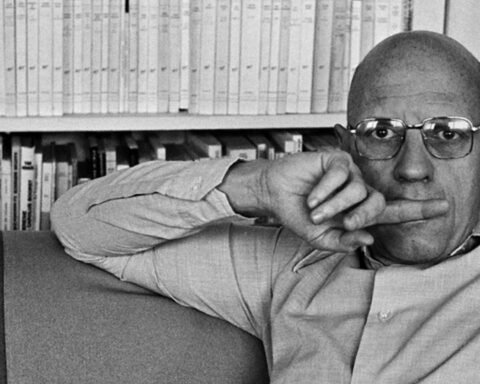


[…] Leggi anche:Sulla natura […]