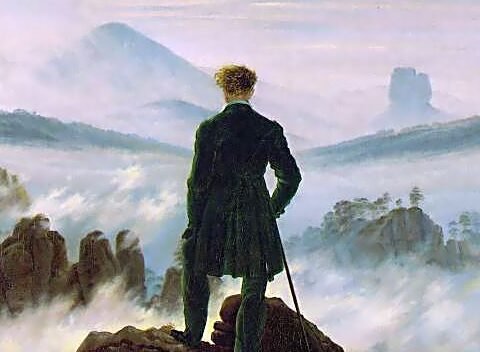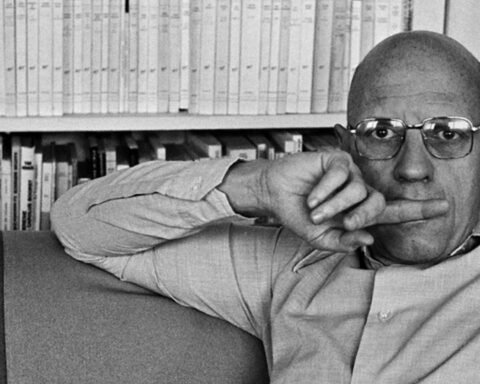A Roma, filosofia era sinonimo di esotismo: scienza “presa in prestito” dalla Grecia, difficilmente veniva considerata come un sapere propriamente speculativo. Ma se non costituiva certo un fine in sé per i Romani, la filosofia era comunque studiata come uno strumento utile, come mezzo per perfezionarsi nell’arte dell’oratoria, della politica e della giurisprudenza.
La filosofia penetrò a Roma dopo che le campagne imperiali ebbero aperto la strada alla Grecia e all’Asia, e più precisamente quando – momento celebre – l’accademico Carneade, lo stoico Diogene e il peripatetico Critolao furono inviati a Roma in ambasceria. Invano Catone il Censore fece allontanare questi pericolosi ospiti, che in un certo senso riportavano la vendetta della Grecia, sconfitta dalle armi, sulla cultura romana: come scrisse Orazio, Graecia capta, ferum victorem cepit, ovvero: «la Grecia conquistata, conquistò il selvaggio conquistatore». Le lettere e la cultura greche, difatti, penetrarono rapidamente a Roma, dove furono accolte con entusiasmo dalle generazioni più giovani.
Ogni scuola di filosofia greca ebbe presto i suoi rappresentanti latini, installando nella capitale dell’impero una sorta di propria colonia. E tuttavia, con il passaggio della filosofia a Roma, quella greca assunse un carattere più pratico, legato alla quotidianità, a quella che veniva chiamata “arte di vivere”. Non erano cioè le questioni speculative a interessare i filosofi romani, ma quelle che potevano influenzare la giusta della vita.
I sistemi che riscossero il maggior favore furono l’epicureismo, l’Accademia antica e media con Cicerone, e soprattutto lo stoicismo. Ognuna di queste correnti che caratterizzarono la filosofia a Roma ebbe un rappresentante celebre, dei quali daremo ora un breve ritratto.