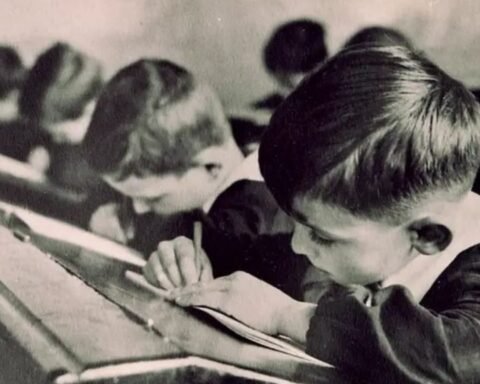L’Europa è divisa in mezzo ai poli di potenze che sanno ciò che vogliono e sanno come ottenerlo. Il fatto che le nazioni europee siano incapaci, invece, di capirlo, è sintomo di una volontà storica che manca. E stavolta non basterà quella di chi, come l’Inghilterra, vorrebbe fare qualcosa; a malapena bastò durante la Seconda Guerra Mondiale quando Londra, per vincerla, dovette vendere tutto l’impero agli Stati Uniti. Stavolta le minacce sono maggiori, vengono da tutte le parti e gli imperi ce li hanno gli altri. C’è poco da girarci attorno: se non si ha la volontà di capirlo ci sono, pronti, gli esempi storici dell’India e della Cina. Se i popoli europei non vogliono che il XXI sia il loro “secolo dell’umiliazione” (non bene, visto che già la prima metà del XX non fu brillante) è necessario che lo si capisca con la dovuta importanza.
Leggi anche:
La notte sull’Europa
Il secolo dell’umiliazione: la storia cinese
“Secolo dell’umiliazione” è un concetto della storiografia cinese che si riferisce al periodo che andò dal 1839 al 1949, in cui la Cina subì l’azione esterna delle potenze occidentali e del Giappone, cadendo in un limbo di divisioni, guerre civili e conquiste straniere. Difficile dire quando tutto ciò ebbe inizio: in fin dei conti, fino alla conclusione del Settecento, la Cina imperiale della dinastia Qing era il centro di un territorio immenso, di un sistema tributario che durava, con le dovute interruzioni, da duemila anni e di un mercato interno che Adam Smith aveva considerato volano della più grande economia del mondo. Ciò che mancava a quella Cina, però, era la consapevolezza storica di un cambiamento. Non è una consapevolezza scontata da acquisire, anche perché per essere significativa deve essere anzitutto condivisa, e poco conta lo spirito guida di un condottiero o di brillanti uomini di stato che, pure, ce ne furono. Ciò che mancava era una società che avesse l’intenzione di fare qualcosa in un mondo in cambiamento. E con una carenza di intenti comuni venne, inevitabilmente, la divisione e, in modo drammatico, l’opportunità per alcuni di sfruttare le minacce esterne come un’occasione personale, inconsapevoli del fatto che, in realtà, stessero lavorando per la loro stessa sottomissione. L’ingerenza straniera iniziò docilmente sulla via dei rapporti commerciali. La dinastia Ming e quella Qing dal XVII secolo in poi avevano mantenuto una politica di chiusura nei confronti del commercio, che consideravano un’attività destabilizzante per il proprio equilibrio interno, ma poco poterono fare quando le potenze europee iniziarono ad adottare la politica delle cannoniere. A poco a poco, quel che era iniziato come l’apertura dei porti per lo scambio divenne una corsa predatoria alla sfera di influenza. Quando nel 1911 la rivoluzione Xinhai rovesciò la dinastia mancese instaurando, in seguito, la repubblica, la situazione era già ampiamente compromessa: dalle macerie dell’impero sorsero le cricche dei signori della guerra e le società civili delle varie prefetture vennero scalzate e sottomesse nella loro debolezza e divisione, acuita, per altro, dagli interessi delle potenze straniere che supportarono ognuna la propria cricca. La repubblica, di fatto, non venne mai unificata e l’equilibrio tra le potenze egemoni venne definitivamente interrotto quando il Giappone, dapprima alleato preposto dell’Inghilterra nel Pacifico, sconvolse l’assetto millenario che dominava la regione: il centro dell’Asia Orientale non era più la Cina, l’Impero Celeste, bensì il Giappone, l’Impero del Sol Levante. Da rapporti di sudditanza economica si era passati a quella politica e, infine, a una guerra totale d’invasione che contò massacri tra i più efferati della storia umana. Quel che è importante notare è l’effetto valanga: la società cinese, i suoi uomini di stato e capi dell’esercito potevano immaginare, nel primo decennio dell’Ottocento, quando i maggiori problemi erano i dubbi rapporti commerciali con gli europei, che tre generazioni dopo si sarebbero ritrovati in uno stato di drammatica sudditanza e impotenza?
Leggi anche:
Quello tra la Cina e la NATO è un rapporto complicato
Il secolo dell’umiliazione come concetto storico
Se volessimo usare il “secolo dell’umiliazione” come un concetto storico universale e non esclusivamente riferito alla Cina, si può dire che anche l’India ha avuto il suo “secolo dell’umiliazione“, contestualizzato alle particolarità storiche del periodo XVIII-XIX secolo. Campo di contesa tra francesi e inglesi fino alla metà del Settecento, la frammentazione politica dei principati indiani, fuoriusciti di fatto dall’impero Moghul, non poterono nulla contro le società civili europee che erano protese all’unico obiettivo di occupare la regione. Il crescente dominio in India da parte della East India Company britannica era foraggiato dal credito, dall’investimento e dal lavoro di una società che credeva fermamente nel valore di quel potere acquisito: persino scozzesi, oltre che inglesi, vedevano in tutto ciò un’opportunità. E i principi indiani, le loro culture cortigiane, vedendo l’espansione britannica, vi intesero una strumentale occasione per il rafforzamento di interessi particolari. La “resistenza” all’avanzata britannica fu parziale e mai concentrata, contando numerose guerre portate avanti dal regno di Mysore o dall’impero Maratha, in altalenante contesa fra loro. Col tempo, l’influenza straniera distrusse la manifattura tessile, l’incuria del regime coloniale provocò carestie e l’ingerenza culturale missionaria precedette l’ammutinamento delle forze indigene come durante la guerra dei sepoys. Alla formalizzazione dell’impero, con la fine della East India Company e il passaggio del controllo della regione all’Indian Civil Service e al vice reame indiano nel 1858, l’India iniziò a sviluppare una società civile e una consapevolezza moderna che superasse il dominio coloniale. Solo a quel punto una volontà storica unitaria pose le basi per un’indipendenza che avvenne nel 1947, ma non prima, costringendo i popoli della regione, per ritardo storico o blanda inconsapevolezza di sé, a centocinquanta anni di dominazione straniera.

Leggi anche:
L’India va alle urne, ma questa volta è diverso
Oggi non è ieri e i fenomeni storici cambiano con le epoche, ma la concettualità del “secolo dell’umiliazione” resta integra come possibile avvenire di ogni popolo o civiltà. Così deve essere anche l’Europa che per il profondo caso della storia si è ritrovata, per quasi mezzo millennio, a ricoprire il ruolo di chi umilia e non dell’umiliato. Ora che la situazione sembra capovolgersi, qualcuno potrebbe dire che è un giusto contrappasso, ma la storia non dovrebbe funzionare per processi vendicativi e nemmeno per ineluttabili destini. Ciò che resta, ad ogni modo, è quella volontà inerte delle società europee che, restando nel contesto della nostra epoca, rima con l’inconsapevolezza e l’impotenza di quelle indiana e cinese. Lo si vede nella mancanza di priorità; nella presunzione di chi crede di poter fare i propri interessi non sapendo di star ponendo le basi per la propria rovina; nella provincialità e nella superficialità delle culture nazionali.
L’Italia e il “parecchio”
L’Europa non ha una comunanza di intenti fra le entità politiche che la compongono, miriadi di identità e interessi si intrecciano. Per non cadere nella trappola delle cricche cinesi e dei principati indiani, credendo ingenuamente di poter domare l’arrivo di potenze esterne a proprio vantaggio, i paesi dovrebbero pensare, quantomeno, una via autonoma e capire che uno stato di minorità porta a un effetto valanga difficilmente reversibile. Fra tutti i paesi, l’Italia, sembra spolverare dal proprio repertorio storico alcuni concetti che hanno segnato il suo difficile cammino all’interno delle questioni internazionali. Dalla crisi odierna, il governo italiano crede che il paese potrebbe ricoprire un ruolo di favore e intermedio, in virtù di una condotta negoziale e delle simpatie personalistiche. In altre parole, l’Italia crede di poter guadagnare “parecchio” dalle vicissitudini in cui è immersa. Questo era, del resto, il pensiero che ebbe Giovanni Giolitti prima dell’entrata nella Grande Guerra: una posizione privilegiata e intermedia che permette di ottenere da tutte le parti fruttuosi benefici. Giolitti pensava, come altri, che l’Italia avesse leve contrattuali sufficienti per far funzionare quella strategia, ovvero annettere territori senza entrare in guerra. Del resto, sia l’Intesa che gli Imperi Centrali avrebbero desiderato Roma dalla propria parte in un conflitto totale che stava portando sul lastrico tutti i belligeranti. Il punto era, come ci si dovette rendere conto alla fine della guerra, che tutto ciò non era vero e che sullo scenario internazionale l’Italia non avrebbe potuto ottenere nulla se non attraverso la buona volontà e la discrezione di altre potenze. Contestualizzando al presente questo spirito nazionale (e tralasciando le complesse vetustà della diplomazia primonovecentesca) resta sempre attuale quella “scappatoia” che l’Italia, un po’ per ignoranza e un po’ per presunzione, cerca assiduamente per smarcarsi dalle proprie responsabilità storiche. La velleità di chi tende mani a tutti – Stati Uniti, Russia, Cina – sperando di ottenere “parecchio” senza sporcarsi le mani e una visione programmatica di lungo periodo, porta a uno stato di minorità che è riflesso del suo popolo e del destino storico che sente di perseguire. Lo stato di minorità o di subalternità è il prodromo dell’effetto valanga e non è la sola Italia, di cui nella sua breve storia unitaria ha dato ampiamente dimostrazione, a doversene vedere, ma è tutto il continente che abitiamo. Per non cadere nella retorica: se i popoli d’Europa vogliono evitare che il XXI sia il loro “secolo dell’umiliazione“, fatto di sottomissione, vassallaggio e trattati ineguali, allora dovrebbero anche evitare di fare gli stessi errori storici che, nei loro contesti passati, fecero India e Cina, ossia credere ingenuamente di poter domare, con gli ossequi e una vanagloriosa politica machiavellica del parecchio, chi ha le idee più chiare e le capacità di ottenere ciò che vuole.
Non abbiamo grandi editori alle spalle. Gli unici nostri padroni sono i lettori. Sostieni la cultura giovane, libera e indipendente: iscriviti al FR Club!
Segui Frammenti Rivista anche su Facebook e Instagram, e iscriviti alla nostra newsletter!