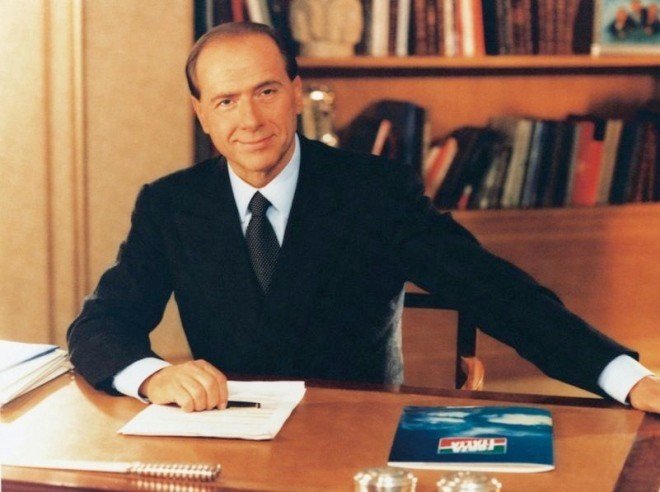Facciamo un salto temporale di 70 anni. Siamo nell’Italia post bellica e post fascista, un Paese che piano piano si ricostruisce politicamente e culturalmente dopo 20 anni di dittatura. È mattino, camminiamo per le strade di un centro città affollato di lavoratori di tutti gli strati sociali. Molte delle persone che vediamo hanno con sé un giornale – spesso è il Corriere della Sera – e alcune di loro, assorte nella lettura, sono completamente nascoste dietro il loro quotidiano formato “lenzuolo”. Per curiosità ne fermiamo uno. «Mi scusi – chiediamo, con cortesia – le parrà strano quanto sto per dirle ma sono un viaggiatore del 2017. Non ci crede? Ecco, le mostro l’edizione del Corriere che ho preso prima di partire. Guardi, osservi bene la data. Mi dica, che ne pensa?».
Quale sarà la sua reazione? Magari non “inorridimento”, ma di certo molta sorpresa. Sicuramente noterà il formato della pagina ridotto – tabloid direbbero gli inglesi, che all’epoca riservavano questa taglia alla pubblicistica popolare –, la presenza di immagini a colori e una certa dose di infografiche che lo lasceranno meravigliato. Tuttavia non ci risparmierà, credo, commenti negativi sulla quantità di pubblicità presente, il minor numero e la brevità degli articoli impaginati – considerati i caratteri più grandi e la maggiore spaziatura dell’interlinea – e la conseguente scarsità di approfondimento nelle questioni trattate. È probabile che sottolineerà la presenza anche di qualche errore di battitura, «ma quello può scappare» gli diciamo e lui pare convinto.
In tutto questo non abbiamo estratto dallo zaino il nostro tablet e, complice l’inesistenza all’epoca della rete 3G, non gli abbiamo mostrato la homepage di corriere.it (o, per farci ancor più del male, quella di liberoquotidiano.it….), risparmiando così il nostro malcapitato del fenomeno delle gallery di donne poco vestite, articoli copincollati dai lanci di agenzia e palate di “infotainment”, ovvero quelle notizie pubblicate con lo scopo di svagare il lettore: il loro contenuto va dal gossip ai video pescati dai social network e garantiscono tonnellate di visualizzazioni a fronte di uno sforzo da parte della redazione pari a zero.
Parrebbe un paradosso ma, a fronte di un numero di lettori che in questi anni ha raggiunto cifre altissime (1 milione e 250 mila utenti singoli al giorno ha visitato la webpage del Corriere nel 2015, 1milione e 631mila quella di Repubblica), i giornali in Italia e nel mondo appaiono sempre più in crisi e al conseguente taglio del personale corrisponde un inevitabile abbassamento della qualità delle notizie riportate. Ma perché succede questo? Soprattutto, come fare a invertire la tendenza?
Julia Cagé, professoressa di economia alla Science Po di Parigi, ha provato a rispondere in un breve saggio dal titolo Salvare i media. Capitalismo, crowdfunding e democrazia pubblicato in Italia nel 2016 da Bompiani. Non si tratta, afferma l’autrice nel testo, di compiere un’operazione nostalgica e antistorica: salvare i media non significa salvare l’informazione su carta stampata. Significa pensare a soluzioni innovative come nuovi statuti legali per le testate giornalistiche che garantiscano gli introiti necessari a un’informazione imparziale, di qualità, accessibile a tutti. Ma prima di tutto occorre liberarsi di alcune illusioni.
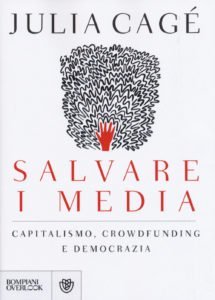
Illusione 1. Più accessi sul web garantiscono più entrate grazie alla pubblicità
Sin dall’inizio della storia dei giornali la pubblicità ha giocato un ruolo fondamentale: permetteva di contenere il prezzo di vendita e allo stesso tempo rendeva la testata indipendente da grandi finanziamenti di origine privata o statale, garantendo così l’imparzialità delle notizie date. Tuttavia ultimamente non è più così.
Dal 2000 a oggi le spese pubblicitarie totali, riferite a tutti i supporti, (misurate in percentuale del Pil) sono in calo continuo. Negli Stati Uniti le entrate pubblicitarie dei giornali sono passate dall’essere lo 0,6% del Pil nel 1987 a poco più dello 0,15% nel 2013. Sempre negli Usa il peso degli annunci pubblicitari è passato dal costituire più dell’80% del volume d’affari totale di quotidiani e riviste nel 2006 a circa il 65% nel 2013. In altre parole: la pubblicità non rende più.
Dall’invenzione di internet a oggi il numero di supporti in grado di ospitare annunci commerciali si è moltiplicato con il conseguente abbassamento dei prezzi degli spazi pubblicitari. Inoltre è chiaro che i giganti del web, come Facebook e Google, in virtù del loro ruolo di grandi aggregatori di contenuti e in grado di proporre all’utente risultati estremamente personalizzati, attireranno sempre maggiori quote di inserzionisti a discapito dei singoli siti web e degli altri supporti come pubblicazioni cartacee, radio o televisione.
Illusione 2. La concorrenza è positiva perché stimola un’informazione imparziale
Nell’industria automobilistica un’azienda, se prospetta un incremento della richiesta del suo nuovo modello di Suv, aumenta il capitale e il numero di operai impiegati così da aumentarne la produzione. Nei media non è così.
L’industria dell’informazione ha infatti costi fissi elevati e rendimenti di scala crescenti. In altre parole: i costi di produzione di un articolo di giornale non aumentano con l’aumentare della quantità dei suoi lettori ma sono invece proporzionali alla qualità del contenuto. Per quanto riguarda invece i più concreti costi di stampa, gli unici a crescere all’aumentare della domanda, questi influiscono in modo minimo sul bilancio di una rivista o di un quotidiano e sono addirittura pari a zero nel caso dei pure internet player – ovvero quei giornali che hanno solo l’edizione online.
La conseguenza economica è che il mercato dei media tende a favorire la formazione di monopoli: pochi grandi gruppi editoriali gestiscono la gran parte del mercato. Il perché è chiaro. Prendiamo l’esempio dell’informazione locale: ipotizziamo che in una data provincia italiana con una popolazione abbastanza omogenea – quindi senza particolari differenze di preferenze tra un quotidiano di destra o di sinistra, più o meno costoso – esista un solo giornale. I giornalisti impiegati sono circa 40, coprono tutte le notizie dallo sport alla cronaca locale e hanno una diffusione, ipotizziamo, di 20 mila copie al giorno. In questo caso siamo in una situazione di monopolio dell’informazione, pericolosa per l’imparzialità delle notizie fornite e per la democrazia. Un gruppo di imprenditori locali decide allora di investire nella nascita di un nuovo quotidiano. Il risultato però è molto più deludente di quanto sperato: il numero totale di lettori di entrambe le testate non aumenta e la tiratura per singolo giornale è di 10mila copie al giorno, ovvero la metà di quella di partenza. Diffusione minore significa anche minori fondi che arrivano dalla pubblicità e l’unica soluzione per rimanere a galla risulta operare un taglio dei posti di lavoro. Da 40 giornalisti le due redazioni passano a 25 giornalisti ciascuna. Il numero di fatti che accadono ogni giorno però non cambia: le due testate tratteranno gli stessi fatti, trascureranno avvenimenti considerati minori, investiranno meno tempo nell’approfondimento e nel fact checking delle notizie.
Questo naturalmente è un caso limite, ma uno studio negli Stati Uniti ha dimostrato una correlazione tra il numero di giornali in una data provincia e la scarsa affluenza alle elezioni locali. La situazione ottimale quindi dovrebbe essere a metà strada tra il monopolio e una concorrenza accentuata: troppe testate significa cittadini meno informati, il che si traduce in una scarsa partecipazione alla vita democratica.
Illusione 3. Con internet i giornali hanno milioni di lettori: il futuro è nell’informazione gratis via web
Parrebbe proprio sia così: in Francia, riporta Julia Cagé nel suo saggio, il numero medio di accessi annui per i siti web dei maggiori quotidiani nazionali francesi è passato da 50 milioni nel 2003 a 180 milioni nel 2013. Il New York Times, sempre nel 2013, vantava 7 milioni di utenti singoli al giorno, ben lontani dai dati della diffusione della sua edizione cartacea ferma a circa 650 mila copie giornaliere. Lo stesso vale per il Corriere: nel maggio 2017 ha totalizzato 1 milione e 151 mila utenti singoli al giorno sul sito web contro una diffusione a giugno dello stesso anno di 220 mila copie cartacee (300 mila se si contano anche gli abbonamenti all’edizione digitale).
Eppure per i quotidiani la rete non è un grande affare. La chiave sta in un altro dato: il tempo speso mediamente dai singoli utenti in rete. Nel 2015 per il Corriere della Sera questo era di 5 minuti e 25 secondi. Un dato che scende a 2’22” per L’Espresso e addirittura a 2’06” per Wired. Estremamente basso! Specialmente se rapportato al tempo speso nella lettura di un quotidiano cartaceo, generalmente compreso tra i 25 e i 35 minuti. Questo dato non influisce solo sul basso livello di approfondimento delle notizie di cui beneficiano gli utenti online, ma anche sulla quantità di attenzione che la pubblicità riceve. Secondo i dati del saggio di Julia Cagé in termini di annunci commerciali un lettore dell’edizione cartacea frutta circa 20 volte più di un internauta. Nel 2012 in Francia le entrate pubblicitarie totali derivate dai siti web dei quotidiani erano del 5% inferiori a quelle delle edizioni cartacee.
Cosa fare? Alcune testate in America hanno proposto abbonamenti che stimolino l’acquisto dell’edizione cartacea (ad esempio facendo pagare meno l’abbonamento online+cartaceo rispetto al corrispettivo solo digitale), ma sono casi isolati. La soluzione più popolare pare invece quella di mettere dei paywall e convincere i propri lettori che un’informazione di qualità merita di essere pagata.

Quali soluzioni? L’associazionismo come via di uscita
Nel 2013 Jeff Bezos, numero uno di Amazon, acquista il Washington Post per 250 milioni di dollari. In molti plaudono all’iniziativa, pronosticando una nuova gilded age, un’epoca d’oro per i giornali in cui i grandi miliardari dell’Hi-Tech decidono di investire nell’informazione. Sebbene una ventata di finanziamenti faccia solo bene ai bilanci in crisi delle redazioni, questo non risolve i problemi di fondo: come assicurare l’imparzialità delle notizie? Come essere sicuri che le intenzioni di questi personaggi siano a fini puramente democratici? Lo stesso vale per gli aiuti di Stato. Come garantire un’indipendenza delle testate dai governi?
Cambiare lo statuto dei giornali, è questa la soluzione proposta da Julia Cagé. Ad oggi la maggior parte di loro sono costituiti in società per azioni. I grandi azionisti godono di un diritto di voto in sede di consiglio di amministrazione proporzionale alla propria quota di capitale. Hanno inoltre il diritto agli utili e alla cessione dei propri titoli. Tuttavia la corsa al profitto dei giornali per migliorare la propria quotazione in borsa e quindi il valore delle azioni detenute porta a cercare di aumentare le vendite a discapito della qualità, come successo a molti grandi quotidiani americani negli anni ’90: grandi avanzi di gestione corrisposero a ingenti tagli al personale.
C’è di più: qualora una testata in crisi trovi come unica soluzione operare una ricapitalizzazione, l’arrivo di un nuovo azionista che “salva” il giornale comporta una diluizione del valore dei titoli preesistenti e comporta uno stravolgimento negli equilibri dei consigli di amministrazione. In altre parole la gestione del quotidiano resta in balia di chi porta il capitale.
Eppure i giornali non sono società commerciali. La loro funzione non è generare profitto ma garantire la sopravvivenza di una vita democratica nei territori in cui operano. Perché allora, propone l’autrice, non dare loro uno statuto simile a quello delle fondazioni? In quel caso il consiglio di amministrazione, regolato dallo statuto fondativo, non subisce modifiche in caso di ingenti donazioni. Queste hanno natura irrevocabile e non danno diritto agli utili.
Nel mondo tra i grandi giornali due sono controllati da fondazioni: l’inglese Guardian (di proprietà della Guardian Media Group, controllata interamente dallo Scott Trust, fondazione no-profit) e il tedesco Frankfurter Allgemeine Zeitung “FAZ” (di proprietà della Bertelsmann Foundation). Quale lo svantaggio? Gli statuti sono difficilmente modificabili nel tempo e spesso, come nel caso del FAZ, attribuiscono la maggior parte dei poteri decisionali al fondatore e ai suoi eredi, generando così delle vere e proprie dinastie e compromettendo l’imparzialità e la buona gestione del giornale.
Occorre quindi ispirarsi alle fondazioni, certo, ma per creare un modello misto in cui da un lato le donazioni abbiano carattere irrevocabile ma che al tempo stesso preveda dei diritti di natura “politica” per i donatori. Tuttavia bisognerebbe superare la logica “un’azione=un voto” alla base del sistema azionistico. Il potere di voto in queste “fondazioni giornalistiche” immaginate da Julia Cagé dovrebbe essere sì distribuito proporzionalmente alle donazioni effettuate, ma in una proporzionalità “corretta”. L’autrice immagina che a fronte di un valore minimo delle donazioni per poter ottenere il diritto di voto, gli azionisti detentori di quote minori abbiano un potere di voto maggiorato laddove invece chi ha devoluto una grossa somma di capitale oltre una certa soglia vede il suo peso politico aumentare in modo inferiore all’aumentare della sua donazione.
In parole semplici uno statuto del genere dovrebbe garantire un maggior peso decisionale a coloro che hanno meno capitale (ad esempio potrebbero esserci delle associazioni di lettori o di giornalisti) e al tempo stesso limitare l’accentramento di potere nelle mani di grandi donatori. Inoltre, grazie allo statuto di fondazione, i finanziatori godrebbero dei diritti di detrazione fiscale che vengono accordati per le donazioni.
Ma quindi con questo sistema si possono salvare i media? Di certo si agevola il finanziamento di piccoli privati e si favorisce la partecipazione dei giornalisti e dei lettori nella gestione di quello che, in fin dei conti, è un vero e proprio servizio pubblico. Giornali e riviste, siano essi disponibili online o in edizione cartacea, sono indispensabili per le nostre democrazie: è dunque indispensabile che anche al loro interno avvenga una gestione trasparente e democratica.