La nuova entrata della bella collana Terra, edita Nottetempo, è il libro Quattro capanne (sottotitolo: o della semplicità) scritto dal giovane filosofo Leonardo Caffo (acquista). Quattro capanne è un libro audace, che sfida e mette in discussione un modo ormai consolidatosi di far filosofia, quello al quale i manuali liceali ci hanno abituati, quello che separa “il pensiero” del filosofo dalla sua vita, dalla sua esistenza, riducendo la seconda ad un’appendice irrilevante della prima. Caffo rovescia quest’ipotesi, e mostra come la vera filosofia non possa che derivare dalla vera vita, dalla vita vissuta sotto il dettame della radicalità di una scelta difficile, travagliata, dolorosa: la scelta della semplicità. La semplicità s’incarna nell’idea di capanna, distacco (parziale) dal mondo, tentativo di ridimensionare sé e gli altri o, come dice Caffo, di uscire dalla complessità – e, ci si domanda, c’è qualcosa di più difficile della semplicità, se la semplicità è questo? Di conseguenza, i quattro personaggi (Henry David Thoreau, Ted Kaczynski, Le Corbusier e Ludwig Wittgenstein) che stanno al centro di Quattro capanne non sono, propriamente, filosofi, o meglio, non lo sono stando a quel canone che la tradizione ci ha consegnato; non sono filosofi proprio perché essi non hanno “prodotto un pensiero”, ma si sono prodotti in una vita, nella quale risiede il nocciolo del loro insegnamento, che Caffo illustra così bene nelle pagine di Quattro capanne. Tanto bene che il saggio detiene la rara virtù di chiamare in causa la nostra vita, la quale, implicitamente, silenziosamente, diventa la questione.
Leggi anche:
Scimmie nude o poco più: il postumano secondo Leonardo Caffo
Abbiamo avuto il piacere di fare due chiacchiere con lui, che ci ha spiegato un po’ di cose sul libro, a chi si rivolge, che idee contiene, e così via. Ecco l’intervista.
La prima questione che vorrei sollevare è quella che sta al centro di Quattro capanne e che funge da struttura portante di tutto il tuo percorso argomentativo. Parlo, ovviamente, della questione che concerne l’intreccio fra filosofia e vita; l’idea di Quattro capanne, al di là di tutto, è quella di riportare la filosofia alla vita, mostrare come esse, teoria e prassi, si leghino indissolubilmente nella vera filosofia. Tu giustamente scrivi da qualche parte che Thoreau, uno dei quattro protagonisti del tuo saggio, non fa filosofia, ma è la filosofia. Ora, se questo è vero, si può supporre che ciò valga anche per te, che Quattro capanne rappresenti anch’esso un tentativo in questa direzione, ossia di ricostruire un allaccio tra filosofia e vita. Vorrei sapere: c’è qualcosa che in te ha scatenato l’esigenza di scrivere questo libro?
«Guarda, quello che è successo a me non è così importante. Sono cose mie, personali, e quindi poco rilevanti perché non universalizzabili. C’è un fatto, però, che sta all’origine di Quattro capanne, e che forse può essere di qualche rilevanza per rispondere alla tua domanda, e cioè che a furia di studiare, insegnare, fare ricerca nei dipartimenti di filosofia, una delle sensazioni che ho avuto è stata quella della distanza tra ciò che insegnavo io, giovane dottorando e poi ricercatore, e ciò che c’era scritto nelle vite dei filosofi, ciò che esse mostravano praticamente, e che io mi ritrovavo a dover spiegare in maniera del tutto asettica. Che ne so, spiegare Ludwig Wittgenstein rimuovendo totalmente le ansie, le preoccupazioni, spesso atroci, che hanno travagliato la sua vita e mosso il suo pensiero: questa dimensione mancava del tutto nel mio insegnamento. Già da studente mi era venuta l’orticaria nel considerare la filosofia come un’attività intellettuale come le altre e non, piuttosto, come pratica, un modo di vivere, un esercizio, cosa che invece è sempre stata, sin dalle sue origini. Cioè, in altri termini, più studiavo filosofia più mi allontanavo dalla vita, entrando in quel circolo vizioso tutto interno all’accademia per cui se non pubblichi compulsivamente non vai avanti.
Così ho cominciato a studiare le vite dei filosofi, trascurando i manuali, ciò che in essi si trova scritto, per cercare di capire proprio come questi personaggi spesso pazzi vivevano, che senso avesse la loro attività prioritaria, il pensiero, perché avessero deciso di far filosofia, e mi sono reso conto che il loro problema non era altro che trovare un modo di stare al mondo nella maniera, diciamo, più semplice possibile, cercare di avere una postura corretta che indirizzasse tutta la loro vita. Mentre leggevo queste cose mi capivo quanto io, invece, fossi lontano da ciò, essendo quello che insegnavo in università infinitamente distante da tutte queste problematiche. Ed è proprio la sensazione di questa lontananza che mi ha indotto a intraprendere la ricerca che sta al centro di Quattro capanne che, se vuoi, è anche una strada per proseguire Fragile umanità, ed è un modo di fare un ritratto più preciso di questi postumani dei quali accenno in conclusione al libro»

In effetti in Quattro capanne si intravede l’idea dell’uscita dall’umano, dell’alternativa possibile alla vita umana, che tu riconduci, per l’appunto, al concetto di “semplicità”.
«Sì sì, è così. A ben vedere, questi filosofi o pensatori hanno cercato con la loro vita di bucare la prassi umana, quella che, si potrebbe dire, “conta”, quella socialmente considerata “giusta”. Il punto è che davvero ti rendi conto, leggendo Wittgenstein, o Thoreau, che se tu rimuovi la vita del filosofo dal complesso della sua filosofia non rimane più niente. E questo è quello che succede in università, dove non si fa altro che argomentare; come fare la settimana enigmistica, ma ad un livello più alto, più intellettualizzato. Questa è la filosofia nelle università oggi»
La cosa è problematica. Tu credi che questa prospettiva – dico, l’idea di un intreccio di filosofia e vita, ossia di una filosofia costruita sulle vite dei filosofi – si possa reintrodurre nell’ambiente accademico? In fondo, si viene su come studenti impregnandosi di questo modo “enigmistico”, diciamo così, di fare filosofia, che è tutto interno al sistema universitario. E quindi è una conseguenza logica che poi non si riesca a vedere la necessità, anzi, l’autenticità, di questo legame tra vita e filosofia. È proprio l’iter formativo, a questo punto, che esclude ciò che invece tu, in Quattro capanne, cerchi di analizzare.
«Sono d’accordo, ed è la cosa più grave, anzi è uno scandalo. I dipartimenti di filosofia oggi c’entrano poco o nulla con la filosofia (tanto è vero che quasi nessuno è semplicemente “Dipartimento di Filosofia”, ma, più spesso, “Filosofia e Scienze della comunicazione”, o “Filosofia e Scienze umane”). Non pensare che io ne sia totalmente fuori, eh. Io mi sono formato studiando filosofia analitica, ho fatto una triennale in logica, un dottorato in filosofia analitica, sostenuto esami di algebra booleana, e non penso affatto la logica sia una cavolata, una cosa inutile, così come non lo sono le funzioni di verità o la teoria argomentativa. Però, ad un certo punto, ti rendi conto che se nei dipartimenti di filosofia si facesse una settimana enigmistica potenziata, ad alto livello, sarebbe un po’ la stessa cosa, e questo proprio perché manca questo nesso tra filosofia e vita. Io, francamente, trovo gravissimo che gli studenti pensino che questa sia la filosofia. Uno studente, oggi, chi si trova in cattedra se vuole studiare filosofia?»
Chiaramente, lo studente di filosofia studierà con professori di filosofia e non con filosofi… che è la cosa più deleteria, perché poi confonde l’uno con l’altro. Senti, ritornando un attimo su quanto hai detto, viene in mente Michel Foucault, che in un certo senso ha incarnato la sua idea di filosofia, no? Foucault parlava di estetica dell’esistenza, ossia di plasmare, come una veste sul corpo, la propria vita sulla filosofia che si pratica. I suoi ultimi, bellissimi corsi al Collège de France sui cinici vanno in questa direzione e in quelle pagine troviamo anche, pur problematicamente, un ritratto dell’intellettuale così come lo concepisce Foucault. Poi in Foucault c’è stato il problema della malattia, come ha vissuto la sua morte, ecc, tutte questioni delicate che, però, hanno anche un senso paradigmatico per il tuo discorso (anche se tu citi mi pare solo una volta Foucault e, comunque, non ne fai un punto di riferimento). Ora, tu credi che si possa reintrodurre in università questo tipo di filosofia?
«Se devo essere sincero, penso che ci voglia una ribellione che provenga dalla parte bassa: gli studenti devono esigere che ciò avvenga, che questa filosofia torni ad essere fatta. Non si può spiegare Nietzsche senza spiegare la sua vita, così come non si può spiegare Foucault senza spiegare la sua vita, come ha vissuto, come ha deciso di agire, cosa ha fatto. Parliamoci chiaro, Foucault è stato nei manicomi, in gioventù ha tentato il suicidio, è arrivato molto tardi alla carriera, ha avuto una vita travagliatissima. Però poi Foucault = biopolitica, no? E allora ecco l’intellettuale che partorisce “la teoria della biopolitica”. Ma che teoria è? A che cosa è connessa? Come si fa a capirlo senza capire Foucault in carne ed ossa, cosa ha visto, cosa ha vissuto? Eh, di questo nelle università è rimasto molto poco…»
Quindi quello che vedi è che senza una ribellione delle masse, degli studenti, questa reintegrazione non può avvenire?
«Il problema è ancora più grave. Dimmi: cosa vai a fare a filosofia in questo momento, perché ti iscrivi a filosofia? Per cosa? Per arrivare a pubblicare quattro articoli in croce su Mind, costruendo un controargomento a un filosofo americano di Berkley? Allora tanto vale che ti iscrivi a chimica, o a ingegneria; almeno il chimico in qualche modo si rende utile, l’ingegnere costruisce un ponte… e il filosofo? Il filosofo cerca la struttura modale di un quantificatore modale… Io queste cose le facevo, le ho fatte per molto tempo. E allora uno ad un certo punto si chiede: ma cosa sta succedendo? La filosofia è nata in modo diverso, perlomeno non da subito plasmandosi sullo stile argomentativo. Tra le cosa più antiche e organiche che la tradizione ci ha lasciato ci sono i dialoghi di Platone, che sono pensati come opere teatrali, come dialoghi, appunto, dove la vita incontra la teoria. È chiaro: serve un cambiamento radicalissimo, estremamente radicale»
Mi trovi perfettamente d’accordo, e in più non c’è un sistema che ci venga dietro. Allora volevo domandarti, in coerenza con quanto ci siamo detti: questa dimensione della ritrovata semplicità della quale tu parli dev’essere anche un’uscita dalla filosofia? In fondo, i quattro di cui parli tu non sono stati filosofi in senso stretto, Wittgenstein escluso… ma anche su Wittgenstein, sulla sua figura, sul suo antiaccademicismo, si potrebbe discutere a lungo.
«È vero, ma pensaci: chi sono stati i filosofi canonici? Walter Benjamin era filosofo? Nietzsche era filosofo? Insegnava filologia, si era formato come filologo classico e uscì prestissimo dall’università per problemi di salute. Oppure, prendi Cartesio. Cartesio, che noi pensiamo come l’iper razionalista, ha elaborato i nodi centrali della sua filosofia a partire da folgorazioni intuitive, anzi, da vere e proprio visioni oniriche. Abbiamo un’idea di filosofia che non esiste – o meglio, alla quale in pochissimi si sono avvicinati (penso a Kant, o Hegel, ma anche su questo si potrebbe discutere). La filosofia in verità è fatta di disgraziati, gente che ha cercato di imparare a vivere, che ha cercato ossessivamente di spiegare qualcosa del senso della realtà. Pensa a che cosa faceva Socrate, dove faceva filosofia, sulla piazza del mercato, bevendo il veleno prima della morte… Wittgenstein e Thoreau cercavano di fare la cosa più difficile di tutte: imparare a vivere, nient’altro. Lo stesso Heidegger, se ci pensi, che pur non era una persona molto quadrata, doveva ritirarsi in solitudine per filosofare, nella sua casetta nella Selva Nera, il che è significativo. Allora, secondo me, è chiaro che ci troviamo ad un bivio: o la filosofia scompare, diventando un’appendice secondaria del critical thinking, o troviamo un modo di ripensarla del tutto. Sennò si tratta soltanto di aspettare che scompaia del tutto…»
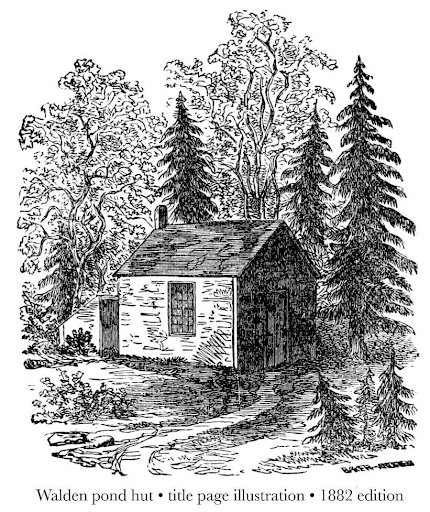
C’è anche da dire che noi italiani, perlomeno a livello accademico, siamo figli di una tradizione, quella gentiliana, che forse ha compromesso quest’idea di filosofia. A ben vedere, c’è un’opera una grande esclusione del discorso filosofico. Autori che, dal tuo punto di vista, sono rilevantissimi proprio perché hanno fatto della vita il campo della loro filosofia, autori come Aldo Leopold o Murray Bookchin, o i padri del conservatorismo americano come John Muir, non sono studiati, non li si conosce…
«…come non si trova Thoreau. Ma nemmeno Wittgenstein si studia mai veramente. O meglio, si studia per le tavole di verità, per la teoria dei colori… che sono problemi del tutto marginali rispetto a quello che ha fatto davvero Wittgenstein, rispetto a quelli che erano i suoi problemi. Come facciamo a trascurarli per capire le cose che dice sulla logica? Così si finisce per convincersi che tavole di verità e teoria dei colori siano la filosofia, che i problema di Wittgenstein quando fu imprigionato a Cassino fossero questi, quando invece il Tractatus logico-philosophicus è un libro nel quale dice che tutto quello che si può dire è, sostanzialmente, nulla, e che la parte fondamentale della vita risiede nel silenzio… invece noi stiamo lì sbattere la testa sul “primo” e sul “secondo” Wittgenstein, sulle tavole di verità e così via. Se lui lo sapesse…»
Un’ultima questione. Dalle tue parole, ma anche dalla lettura di Quattro capanne, penso che emerga chiaramente un’idea molto importante, ossia l’idea che per raggiungere la semplicità, per filosofare, si debba fare violenza a se stessi. Come dicevi tu: il sistema va sovvertito. Detto in altri termini: bisogna fare violenza a come si fa ora la filosofia, e, credo, questo è un po’ il riflesso di ciò che i 4 personaggi di cui tu parli in Quattro capanne hanno fatto con se stessi: la semplicità è un travaglio, comporta dolori, rimorsi, nostalgie, paure. Cosa pensi di questo?
«Io sono convintissimo che una delle prime cose necessarie per uscire da un paradigma, da uno stile di vita a cui si è assuefatti, da una prassi deleteria, è proprio fare una violenza enorme su se stessi, sul proprio linguaggio, sulle proprie pratiche di vita. È chiaro: uscire da una certa prassi è faticosissimo: devi, in un certo senso, violentare te stessi. Prova a pensare alle 4 vite che descrivo nel libro: almeno 3 di queste (lasciamo stare Le Corbusier, che è un caso a parte), sono state delle vite di enorme sofferenza. Sia Thoreau, sia Kaczynski sia Wittgenstein erano dei disgraziati, persone costrette, non solo da se stesse, ad uscire da una prassi. Ed è ingannevole studiarle in modo asettico, ad esempio prendere Walden come un diario su quanto è bella la natura, o Wittgenstein, come già detto, come un semplice logico, o, ancora, Unabomber un matto terrorista. In questo modo ci dimentichiamo di tutto il resto, che, come ci insegna Wittgenstein, è la parte più importante. Ci dimentichiamo cioè che la ricerca della filosofia è una grande violenza su te stesso: per imparare a pensare devi disabiturarti a pensare come ti è stato insegnato. È un’operazione violentissima, quasi come rinnegare il padre e la madre per educare tuo figlio: devi cambiare il sistema entro il quale sei nato e cresciuto. Per citare un’immagine che utilizzo in Fragile umanità, è come entrare in un labirinto estremamente faticoso per poi accorgersi, solo a giochi compiuti, che era meglio non farlo. La filosofia è esattamente questo»
Ci vuole coraggio…
«Sì, ce ne vuole tantissimo».
Segui Frammenti Rivista anche su Facebook, Instagram e Spotify, e iscriviti alla nostra Newsletter
Sì, lo sappiamo. Te lo chiedono già tutti. Però è vero: anche se tu lo leggi gratis, fare un giornale online ha dei costi. Frammenti Rivista è edita da una piccola associazione culturale no profit, Il fascino degli intellettuali. Non abbiamo grandi editori alle spalle. Non abbiamo pubblicità. Per questo te lo chiediamo: se ti piace quello che facciamo, puoi iscriverti al FR Club o sostenerci con una donazione. Libera, a tua scelta. Anche solo 1 euro per noi è molto importante, per poter continuare a essere indipendenti, con la sola forza dei nostri lettori alle spalle.









