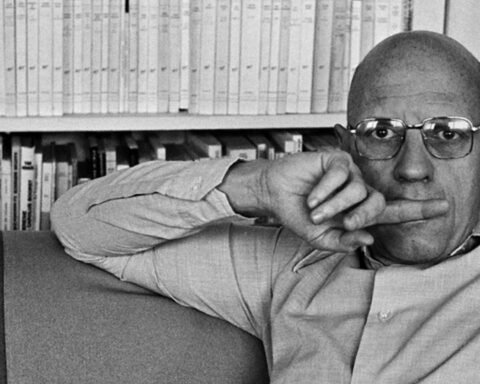Palomar, ultimo romanzo di Italo Calvino pubblicato nel 1983, incarna forse la traduzione in prosa – anche se in quel tipo di prosa che sfiora e, per dirla con Niccolò Machiavelli, «sdrucciola» in ambiti non prettamente letterari, ma metafisici appunto – dell’ideale filosofico dell’elogio della razionalità umana.
Già Aristotele ebbe modo di notare, con la sua solita acutezza, che per natura l’uomo è spinto da un profondo desiderio di conoscenza; che poi questa abbia per oggetto il più alto dei saperi (la metafisica, che ragiona intorno a “ciò che è di per sé immutabile”, secondo lo Stagirita) o altresì il più basso di questi non importa. Sta di fatto che non ci si può astenere dall’accrescere il proprio bagaglio conoscitivo e basta un poco rifletterci sopra per dare ragione ad Aristotele.
Apparso in frammenti sul Corriere della Sera e corredato di aggiunte successive, Palomar rappresenta con tutta probabilità il vertice della tensione post-moderna che accompagna gli ultimi scritti di Calvino, ove finzione e realtà vengono ad intrecciarsi, corredate da una spiccata sensibilità nei confronti del quotidiano. Le pretese non hanno del titanico, Calvino non volle emulare i grandi maestri del racconto argentini da lui conosciuti ed ammirati – tentativo questo confluito, a parere di chi scrive, in Se una notte d’inverno un viaggiatore – quanto piuttosto inglobare in una prosa che sfocia talvolta nel poetico, talaltra nel filosofico, quell’intimo sentimento che fa uomo l’uomo e non bestia, il sentimento del quieto osservare, del lento riflettere, del ruminare, per dirla con Friedrich Nietzsche.
«Uomo nervoso che vive in un mondo frenetico e congestionato, il signor Palomar tende a ridurre le proprie relazioni col mondo esterno e per difendersi dalla nevrastenia generale cerca quanto più può di tenere le sue sensazioni sotto controllo». Cerca una via di fuga, il signor Palomar, una fuga da quel mondo che si è dimenticato di prendersi una pausa, accalcato nella frenesia della chiacchiera quotidiana.
E la fuga la trova nella contemplazione: i capitoli del testo descrivono le esperienze di senso (visive, uditive, intellettuali) che accompagnano il signor Palomar fra i giardini di uno zoo ad osservare, insieme alla moglie e alla figlia, giraffe, scimpanzé e tartarughe; fra le frasche del suo cortile ove il tempo è scandito dal canto dei merli che posano sui i rami degli alberi; fra la gente, a far la coda dal macellaio; sulla spiaggia a gettare fugaci occhiate al seno scoperto di una giovane donna, meditando sul come atteggiarsi per non essere troppo invadente né menefreghista, mostrando di apprezzare la vista ma con pudore e riservatezza, ricercando quella fine discrezione che rende giustizia alla bellezza. Chiaramente la ragazza si alza e se ne va. Il signor Palomar ha imparato quindi che nella vita è importante osservare.
Scrupolosamente, spesso vinto dal nervosismo e dall’impazienza, si impone di prestare attenzione a ciò che la sua vista cattura. A ribadire nella finzione romanzesca il pesante nome che porta sulle spalle (nome il suo condiviso con un famosissimo osservatorio astronomico americano) il signor Palomar traduce in riflessioni cosmiche il frutto del lento riposare degli occhi sulle minuzie naturali delle quali per la maggiore non ci si accorge: dopo aver osservato lungamente il vasto prato che circonda casa sua «s’è distratto, non pensa più al prato: pensa all’universo. Sta provando ad applicare all’universo tutto quello che ha pensato del prato. L’universo forse finito ma innumerabile, instabile nei suoi confini, che apre entro si sé altri universi».
«Oh, felice chi può con vigorose piume| balzar verso le lande luminose e serene;| e sente come allodole, nei cieli alti perdute,| i suoi pensieri all’alba liberamente ascendere,| e plana sulla vita e senza pena intende| il linguaggio dei fiori e delle cose mute!». Questi versi contenuti ne I fiori del male, capolavoro poetico di Charles Baudelaire, descrivono esattamente l’intento del signor Palomar, che «intende il linguaggio dei fiori e delle cose mute». Un bel passo ritrae Palomar sul far del tramonto in spiaggia, a scrutare l’inesorabile movimento delle onde:
«Siccome ciò che il signor Palomar intende fare in questo momento è semplicemente vedere un’onda, cioè cogliere tutte le sue componenti simultanee senza trascurarne nessuna, il suo sguardo si soffermerà sul movimento dell’acqua che batte sulla riva finché potrà registrare aspetti che non aveva colto prima; appena s’accorgerà che le immagini si ripetono saprà d’aver visto tutto quel che voleva vedere e potrà smettere».
Ma Palomar, come in fondo l’umano in genere, non smetterà di vedere; mai il sentimento di appagamento potrà ricolmarlo lasciando spazio ad una quanto meno inesatta saturazione interiore. Calvino stesso, nell’introduzione al romanzo, ammette con parole efficacissime l’implicita traccia che segue il testo: «Rileggendo il tutto [ossia il testo compiuto], m’accorgo che la storia di Palomar si può riassumere in due frasi: un uomo si mette in marcia per raggiungere, passo a passo, la saggezza. Non è ancora arrivato».
Che si tratti in fondo della stessa vicenda narrata dall’Ulisse dantesco è ben chiaro. Di certo con Palomar non ci ritroviamo fra i dannati dell’Inferno e nemmeno fra le fiamme dell’ottava bolgia ove sono arsi i consiglieri fraudolenti ma entrambi – Ulisse e il signor Palomar – ci insegnano che «fatti non fummo a viver come bruti, ma per seguir virtute e canoscenza». Forse Calvino volle tacere questo parallelismo, o almeno renderlo implicito, proprio per risvegliare noi lettori, ancora una volta, a guardare al fondo del nostro essere per scorgervi l’indomita volontà di conoscenza che ci anima, troppo spesso dissipata nel frenetico vivere quotidiano.
Giovanni Fava