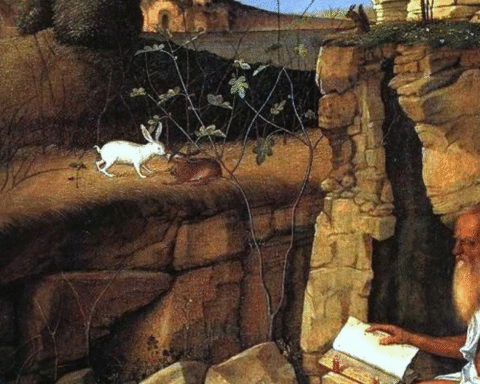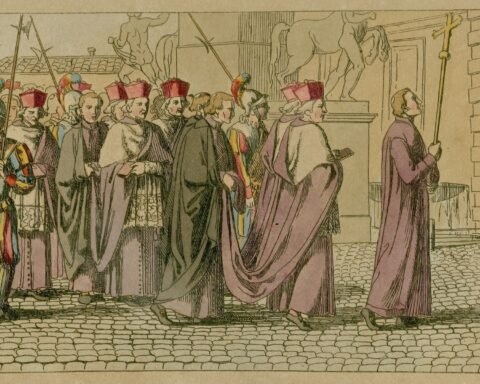Provate a chiedervi: chi incarna la Resistenza? È una ragazza che corre tra i papaveri, coi polpacci contratti e la gonna che si gonfia al vento, perché la guerra sta finendo? È un uomo di mezza età con la barba incolta che riflette silenzioso appoggiato al fucile in un giorno di pioggia? È un bambino che nasce nella primavera del 1945 e sembra con una risata chiamare a raccolta i fondatori di una nuova Italia? Solo tre immagini stereotipate, ma di cui abbiamo bisogno ora più che mai. Perché siamo arrivati all’appuntamento e stavolta è pure un decennale. Un ottantesimo, quasi la speranza di vita media in Italia (84 anni per gli uomini, 85 per le donne): significa che è quasi passata una vita da quel 25 aprile invecchiato male. E noi, stanchi, infastiditi, indignati, siamo qui, a non mollare un colpo. Anno dopo anno parlare di Liberazione e Resistenza diventa più impegnativo, perché dobbiamo reinventarci, a differenza degli anti-antifascisti che sembrano trovare ogni giorno una via più efficace per rosicchiare le fondamenta di quello che stiamo provando a costruire, perché non hanno fatto altro che correrci dietro e guardare dove siamo inciampati.
È difficile stare in bilico su quel crinale che da un lato sprofonda nella retorica vuota e dall’altro si allontana troppo da una ritualità che deve iniziare a far parte di questa celebrazione – altrimenti che festa nazionale sarebbe? Ci siamo noi qua in mezzo, con un lumicino nella nebbia cercando di non mettere male il piede e cadere; dietro si sente l’abbaiare di quel passato tremendo che sembra un futuro sempre più vicino. Come si fa a non finire di sotto? Bisogna essere in tanti, legati in una cordata, così possiamo avere meno paura e cercare nel cuore di un partigiano ottanta parole di Liberazione e Resistenza.
Dato che siamo d’accordo con quello che hanno fatto, partiamo da qualcosa di bello: magari la felicità e la commozione perché si pensava alla fine della guerra, di speranza per un presente e un futuro migliori. La bellezza dei boschi, delle montagne e delle città quando sembravano far di tutto per proteggere i partigiani (un bosco antifascista, che idea bella), la sorpresa di incontrare un aiuto inaspettato e l’allegria dei momenti spensierati che ci furono. L’amore che sbocciava tra i resistenti, o quello che portava gli innamorati a lasciare tutto per unirsi a qualcuno che aveva scelto la lotta. Una lotta fatta di silenzi, noia e attese, buio impenetrabile e notti a contare le stelle (pure quelle sui cappelli dei comunisti). O notti a sognare il domani, perché chissà come lo rifaremo questo Paese, che non si ricorda bene cosa vuol dire scegliere. Una vita a testa china a obbedire oppure a stringere il fucile, la bicicletta, il libro, i messaggi da portare di nascosto, la mano del compagno morente o la propria bocca per non urlare davanti ai corpi crocifissi sul palo del telegrafo.
Leggi anche:
Le altre Resistenze
Perché ogni tanto gli occhi bisognava chiuderli lo stesso, e non per sognare la nuova Italia, ma per non vedere i tradimenti di quelli che sembravano amici e amori di una vita e che invece andavano a spifferare dove si nascondessero i partigiani in cambio di un tozzo di pane in più, magari andavano anche capiti e una parte di te diceva “che ci fai ancora qua a dormire al freddo, che ti costa andare anche tu coi cattivi?” e forse soffrivi per quello. Chiudevi gli occhi perché avevi davanti il corpo che avevi ucciso per vendetta dopo vent’anni e passa di dittatura, forse pure un corpo innocente o il corpo di un ragazzino. Chiudevi gli occhi perché avevi rinunciato a tantissimo per degli ideali che a volte ti sembrano un po’ stupidi, e a volte ti senti l’unico a crederci. Chiudevi gli occhi perché avevi una paura matta, del freddo, della morte, delle ferite che si infettavano, delle torture, di quel che poteva star succedendo alla tua famiglia in città, e a volte delle ombre che ti sembravano i mostri di quando eri bambino.
Poi la paura va via, per qualcuno mentre si dorme e per qualcuno mentre si combatte, e allora col fucile in mano ti senti un eroe che lotta per la patria e la nazione (quelle vere, non quelle dei patrioti finti di oggi che si riempiono la bocca di parolone grosse e romantiche di questo tipo dopo avercele svuotate di senso), per i valori grossi come l’uguaglianza e la libertà (questi vengono dritti dalla Rivoluzione francese, ma poi se dici quello che pensi davvero di Robespierre ti guardano male) e la giustizia e la libertà e la democrazia eccetera. Forse già che ci siamo ci ficchiamo dentro pure la rivoluzione (nostra, non francese), così poi tutti quanti hanno il lavoro e da mangiare. Poi ti sparano e ti svegli perché stavi solo sognando.
Che pesante sei, sempre a parlare di queste cose elevate, ma guarda che bello il cielo, guarda che senza accorgerti questa faccenda della Resistenza sui monti a sparare ai fascisti e a sognare il futuro sta diventando per te quotidianità e tornare a quella che chiameranno normalità sarà alienante. E magari sei pure una donna che sta inspirando la libertà e l’emancipazione per la prima volta dopo quello schifo di dittatura e a casa ti aspetta un uomo che ti dirà di startene zitta dopo che tu hai sconfitto Mussolini e i suoi amichetti. Pure rispondergli di starsene zitto lui è antifascismo.
È antifascismo pure sederci oggi, un momento, a pensare a cosa stiamo sbagliando. Parole, gesti, chiusure, aperture, amnistie, discorsi. Bisogna fermarsi e capire due cose: chi sta dalla nostra parte e come far capire che la Liberazione è la festa più importante dell’anno. Ognuno, proprio come i partigiani, deve trovare dentro di sé la motivazione per cui questa festa ha un senso. E poi bisogna rivolgere la domanda a figli e studenti, perché appena ci guardiamo intorno ci accorgiamo che non può bastare il paragrafetto sul libro di storia per dire di aver parlato di Resistenza e Liberazione. La lotta partigiana, figurata e fisica, va insegnata sollevando questioni etiche sulle scelte di vita e sull’esempio del passato, sulla nostra personale e unica idea di sacrificio e di dovere. Perché altrettanto personale e unica è stata la Resistenza, e starà poi a ognuno scegliere se si trattò di martirio o no, se fare della Liberazione una pedagogia, una maestra, una strada.
Leggi anche:
10 libri per capire la Resistenza
La bellezza di quei due anni di guerra civile (che paradosso!) e di venticinque e passa anni di antifascismo si alimenta e si riaccende con la letteratura, il cinema, la musica, l’arte e la divulgazione. Perché là fuori c’è un prodotto della Resistenza adatto a ognuno, basta avere le giuste guide per trovarlo e suscitare un’emozione per rinnovare l’idea di cura che stava dietro alla lotta. Però ci dicono che dobbiamo fare le cerimonie sobrie. Perché tutto quello che ci siamo raccontati qua sopra non piace a tutti ed è anche un po’ ridicolo che alcuni di questi abbiano in mano il governo del Paese, ma si sa che la Storia è così e che la Resistenza è permanente. Per questo, ora più che mai, il nostro 25 aprile e la nostra Liberazione sono lotta e augurio. Per un futuro diverso dal presente.
Queste ottanta parole in grassetto sono semi della Liberazione. Non bastano e non basteranno mai a spiegarla, ma da ognuno può nascere un albero. Nostro dovere piantarlo e accudirlo. Che sia in “deliri” come questo o in lezioni, discussioni, chiacchierate, litigate, manoscritti, post, didascalie, urla da ubriachi, scritte sui muri, dobbiamo fare in modo di propagare ciò che per noi è Resistenza.
Non abbiamo grandi editori alle spalle. Gli unici nostri padroni sono i lettori. Sostieni la cultura giovane, libera e indipendente: iscriviti al FR Club!
Segui Frammenti Rivista anche su Facebook e Instagram, e iscriviti alla nostra newsletter!