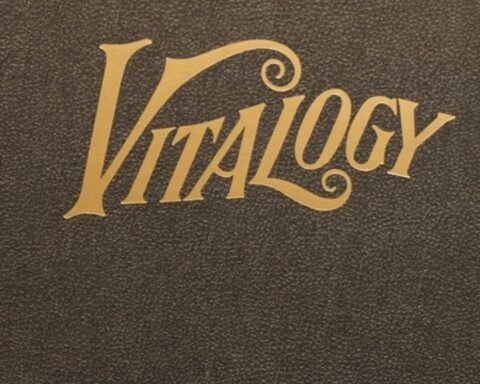Il ricordo della Resistenza italiana viene sempre cantando. Non si può scindere il movimento di opposizione al nazifascismo dalle musiche che lo hanno alimentato. I canti della Resistenza italiana non furono solo colonna sonora della lotta contro il nazifascismo, ma anche testimonianze in versi e melodia di un’intera generazione e di un’epoca segnata dal coraggio, dalla paura e da una forte speranza. I canti partigiani raccontano la storia dal basso, dalle valli e dalle montagne: lì dove la libertà si scriveva con il rischio quotidiano e si cantava per sentirsi meno soli. Il canto più noto è senza dubbio Bella Ciao, nato come canto popolare contro l’invasore nazifascista e divenuto un simbolo universale di resistenza e libertà. Tuttavia, il patrimonio musicale della lotta partigiana è molto più vasto e sfaccettato e ci restituisce una memoria sonora che merita di essere riscoperta.
Leggi anche:
Liberarsi di noi: la Resistenza in Abissinia
I primi canti, tra riadattamenti e originalità
Fischia il vento fu la prima vera canzone partigiana, diffusa ufficialmente dopo l’armistizio del generale Pietro Badoglio, l’8 settembre 1943, quando, di fatto, iniziò la Resistenza. Sebbene fino a quel momento non esistessero vere e proprie canzoni partigiane, dei canti venivano intonati ugualmente. Si riproponevano o riadattavano, ad esempio, i vecchi canti socialisti e comunisti, come La guardia rossa e Bandiera rossa, ma anche di origine anarchica, come Addio Lugano Bella, che fu trasformata in Addio Imperia Bella. Con Fischia il vento il movimento partigiano ebbe finalmente anche una chiara denotazione musicale. Il testo fu scritto da Felice Cascione, nome di battaglia Megu, giovane medico ligure con una passione per la poesia. L’ispirazione arrivò a Bologna, poco prima dell’8 settembre 1943. La melodia ricalca invece quella di Katjuša, canzone popolare sovietica che un reduce dalla campagna di Russia, Giacomo Sibilla (Ivan), aveva appreso sul Don. Il brano fu adattato sulle montagne liguri — prima al Passu du Beu, poi al Casone dei Crovi — grazie anche alla collaborazione di altri combattenti, come Vittorio Rubicone (il Biondo) e Silvano Alterisio (Vassili). «Fischia il vento e infuria la bufera, scarpe rotte eppur bisogna andar»: versi semplici e taglienti, che divennero l’inno ufficiale delle Brigate Garibaldi, accompagnando le marce, le azioni e le veglie nelle notti gelide del 1943.
Leggi anche:
10 libri per capire la Resistenza
Insieme a Fischia il vento, Siamo i ribelli della montagna è uno dei pochi brani partigiani originali di cui si conoscono chiaramente gli autori e il contesto di nascita. Composto nel marzo del 1944 alla Cascina Grilla, nei pressi del Monte Tobbio (provincia di Alessandria), fu frutto del talento di Emilio Casalini (Cini), autore del testo, e di Angelo Rossi (Lanfranco), giovane partigiano con studi musicali alle spalle. I due scrissero i versi su carta da pacchi, durante un turno di guardia. La canzone, intensa e potente, si diffuse rapidamente tra le formazioni della VI zona “Genova”, per poi divenire uno degli inni della Brigata Mingo. Nella sua semplicità, il testo trasmette lo spirito collettivo della Resistenza, con un orgoglio che non si piega, nemmeno di fronte alla morte: «siamo i ribelli della montagna / viviamo di stenti e di patimenti».
In quegli anni si diffuse anche Figli di nessuno, canto di probabile origine militare, presente nel repertorio degli alpini, ma reinterpretato in chiave partigiana intorno al 1943, soprattutto in Liguria e Piemonte. Intonato sull’aria di Figli dell’officina, il brano racconta la condizione di chi combatteva fuori da ogni riconoscimento ufficiale, ai margini della società e della legalità: “figli di nessuno”, come venivano chiamate le squadre d’azione più radicali, già attive contro il fascismo sin dagli anni ’20. Un canto che incarna l’identità ribelle e clandestina di una parte della Resistenza.
Satira, ironia e dissenso
Non tutti i canti della Resistenza avevano toni solenni o epici. Alcuni, come La Badoglieide, facevano della satira politica la loro forza. Composta nella notte tra il 25 e il 26 aprile 1944 da un gruppo di partigiani della Quarta Banda di Giustizia e Libertà, il brano prendeva di mira Pietro Badoglio, capo del governo dopo la caduta del fascismo, colpevole agli occhi di molti resistenti di ambiguità e tradimento. La canzone nacque da un’improvvisazione sulla melodia della canzonetta E non vedi che sono toscano, subito trasformata in canto partigiano da Nuto Revelli, Ivanoe Bellino, Alberto e Livio Bianco e Nino Monaco. Con toni pungenti e dissacranti, La Badoglieide esprimeva la delusione per una transizione che, agli occhi dei partigiani, rischiava di lasciare intatte le vecchie strutture di potere.
Leggi anche:
In memoria del 25 aprile: i luoghi della Resistenza
Durante la guerra partigiana, anche la musica leggera veniva reinterpretata, spesso con spirito ironico o allusivo. È il caso di È arrivata la bufera di Renato Rascel, canzone apparentemente disimpegnata che però, intonata dai partigiani, assumeva un significato del tutto diverso: rievocava i bombardamenti americani, la precarietà della vita quotidiana, ma anche la fine imminente del conflitto.
Non abbiamo grandi editori alle spalle. Gli unici nostri padroni sono i lettori. Sostieni la cultura giovane, libera e indipendente: iscriviti al FR Club!
Segui Frammenti Rivista anche su Facebook e Instagram, e iscriviti alla nostra newsletter!