L’arte cinematografica come arte delle immagini in movimento si è sempre rivelata estremamente funzionale alla rappresentazione della violenza forse perché unisce la capacità dell’immagine di essere di per sé violenta in quanto direttamente votata ad essere percepita dal nostro organo più sensibile o da quello che la tradizione culturale ha privilegiato creando una sorta di equivalenza tra la conoscenza e la possibilità di vedere, la non conoscenza e una sorta di cecità o di buio.
Questo articolo vale solo come spunto per una riflessione a venire. Non potrebbe essere altrimenti dato che la complessità dell’argomento necessita di uno spazio e di una meditazione che il genere dell’articolo non permette. La presenza della violenza nella narrazione cinematografica si interseca con la riflessione su arte e morale (sulla quale mi riservo di scrivere in futuro) e in generale con il tema della rappresentazione della violenza per immagini, dalla storia dell’arte ai servizi giornalistici, dalla televisione a Youtube.
La violenza al cinema potrebbe essere analizzata secondo diverse macro-categorie; ne individuo subito quattro, riservandomi approfondimenti e correzioni in un prossimo futuro: etnica, evocata, naturale, recondita.
La violenza etnica
Nella narrazione cinematografica può capitare che l’attitudine alla violenza venga considerata costitutiva di certi gruppi etnici; questa visione si intreccia e finisce con l’alimentare che si voglia o no il pregiudizio o quantomeno la stereotipizzazione di taluni gruppi umani; è il caso ad esempio della lunga serie di film gangster o di film sulla mafia che a partire specialmente da Il Padrino di Francis Ford Coppola ha alimentato l’idea secondo la quale una sorta di aggressività naturale fosse insita nel popolo italiano, in connessione con l’attitudine criminale. In una serie tv come I Soprano, ad esempio, sotto la superficie ironica si nasconde una iperritualizzazione estetizzante dell’aggressività, una ritualizzazione che riporta l’aggressività come dato di appartenenza innanzitutto alla famiglia mafiosa protagonista della serie, quella dei Soprano le cui origini italiane sono ribadite di continuo, dall’altra come dato di appartenenza a un gruppo etnico in generale.
Nella serie la presunta “aggressività all’italiana” è ritualizzata secondo diversi sistemi rappresentativo-narrativi: da un lato l’aggressività viene presentata come dato caratterizzante anche quei soggetti estranei all’attività criminale ma che hanno in comune l’italianità o l’appartenenza di sangue alla famiglia Soprano: è il caso della sorella di Tony, donna irascibile e omicida per caso, il cuoco italoamericano amico di Tony che finisce per fare a botte con un uomo del clan, la stessa psicanalista di origini italiane che sogna il suo violentatore azzannato dal tipo di cane adottato dai soldati nell’Antica Roma e che dunque, inconsciamente, desidera non la giustizia dello Stato Americano ma la vendetta della mafia italiana.
Dall’altra l’appartenenza italiana viene ritualizzata attraverso lo scontro violento con altre etnìe di immigrati, dal primo omicidio di Christopher Moltisanti (nipote e uomo di fiducia di Tony Soprano) compiuto ai danni di un cecoslovacco, alla sorella di Tony che ingaggia una feroce lotta con una badante est-europea, alla scazzottata del cugino di Tony con un coreano. Gli esempi sarebbero innumerevoli nell’intera e copiosa filmografia gangster ma resta il fatto che la cinematografca che ha focalizzato l’attenzione sul crimine organizzato di origine italiana si è posta come elemento imprescindibile per qualsiasi altra riflessione cinematografica sulla violenza dei gruppi etnici.
Il Padrino presentava profonde implicazioni etniche e costituì un modello per successive opere cinematografiche in cui altri gruppi etnici venivano presentati come violenti; si pensi a i cubani di Scarface (1983) o a i sinoamericani di L’anno del dragone (1985). Ma nel caso di Scarface o, ancora, dei russo-siberiani di Educazione Siberiana, a differenza che nei film sugli italoamericani la violenza sembra avere di volta in volta una giustificazione sociale o vagamente politica mai essere un’espressione del sangue o di una ritualizzazione dell’appartenenza etnica come nei film sulla criminalità italoamericana. Tale filmografia rimane dunque imprescindibile come punto di riferimento non solo per una riflessione sul cinema etnico ma soprattutto sulla capacità dello spettacolo cinematografico di distorcere la percezione della violenza attribuendola, in questo caso, a determinati gruppi umani nel vano tentativo di rassicurane altri sulla propria presunta superiorità etica o civile.
La violenza evocata
In alcuni film la violenza, più che essere descritta, viene semplicemente evocata. La parsimonia nell’esposizione della violenza al cinema è legata storicamente a ragioni di carattere morale ma, tale modalità, funziona in quanto costringe il pubblico a supplire con la fantasia alla carenza visiva. Tale coinvolgimento in termini di immaginazione induce lo spettatore a contribuire direttamente alla rappresentazione.
In film quali Dogville (2003, di Lars Von Trier) o Manderlay (2005, di Lars Von Trier) Gandini ritrova «un’illustrazione delle modalità con cui i meccanismi della sovranità popolare partoriscono, legittimano e realizzano atti di violenza ai danni del singolo», dunque, continua lo studioso, è a tale
«idea della sovrapposizione fra violenza e diritto che si attiene lo stile dei film, nei quali i momenti di aggressività e sopraffazione vengono rappresentati con la medesima, inesorabile pacatezza con cui il popolo di Dogville e quello di Manderlay emettono le loro sentenze di morte, schiavismo e punizione corporale». Visivamente la rappresentazione della brutalità sottostà «al principio di astrazione e razionalizzazione che governa i due film sul piano tematico, caratterizzandosi come un evento inessenziale, prosaico, ancorato alle ordinarie dinamiche di amministrazione democratica di una comunità. La violenza perde qui completamente i suoi tratti di sregolatezza, innanzitutto nel senso etimologico del termine, poiché entrambi i film ci mostrano come essa di fatto sia né più né meno che una regola, in virtù della quale viene tutelato il benessere delle due comunità».
Ancora Gandini sostiene «la forma determina una distanza che permette al regista di sollecitare lo spettatore non tanto a guardare la violenza, quanto a guardare alla violenza, vagliandone cause e conseguenze che la generano e diffondono». Gli aspetti violenti e sensazionalistici che toccano l’emotività degli spettatori vengono qui decisamente limitati nel tentativo di «rendere lo spettacolare non spettacolare». Secondo Gandini, in tali opere, si attua un doppio atto di negazione.
«Da una parte viene rinnegata l’immediatezza propria delle fotografie più cruente sull’argomento, dall’altra sono ripudiate le occorrenze stilistiche e narrative che corredano abitualmente la rappresentazione cinematografica del tema. È necessario, per dare risalto alla violenza e renderla nuovamente eccezionale, calarla in un contesto nel quale il cinema possa guardarla – e farla guardare agli spettatori – come fosse la prima volta”. Attraverso la strada dell’astrazione, nel danese, e della rimediazione, nello statunitense, tali opere determinano “un effetto straniante, indispensabile in un’epoca nella quale i media affrontano il tema dispensando a getto continuo visioni sempre più stereotipate a beneficio di spettatori sempre più distratti».
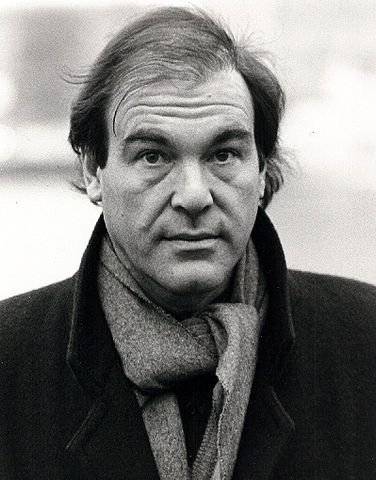
Gandini affronta anche il film austriaco Funny Games (1997, di Michael Haneke) – di cui esiste un remake americano del 2007, ad opera dello stesso regista – opera in cui la violenza tende, per lunghi tratti, ad essere nascosta allo sguardo dello spettatore. Tale espediente, secondo Gandini,
«accorcia ulteriormente la distanza fra i due personaggi e il regista, poiché alla fredda crudeltà con cui Haneke distilla la violenza ai suoi spettatori si unisce l’impressione, generata appunto dagli sguardi in macchina, che i due ragazzi operino da registi interni della vicenda, dettandone tempi e modi anche alla macchina da presa, nella piena consapevolezza che ‘lì fuori’, oltre lo schermo, qualcuno li sta guardando».
In Funny Games si giunge a «dare al pubblico un assaggio di quello che il film, sotto il profilo estetico, non vuole essere»: si tratta della scena, girata e montata in maniera diversa dal resto del film, in cui la protagonista riesce a sparare alla testa di uno dei due giovani comportando l’affannosa ricerca, da parte dell’altro ragazzo, del telecomando per
«riavvolgere gli eventi…. La natura convenzionale del frammento espulso non riguarda (…) solo il piano stilistico ma anche quello narrativo, poiché la scena vede la vittima ribellarsi e vendicarsi del suo carnefice. La vicenda dunque ritrova qui, sia pure solo per un pugno di inquadrature, una logica morale, basata sulla ritorsione».
Riflettendo sul frammento “anomalo” di Funny Games, Gandini sottolinea come lo spettatore giustifichi il ricorso alla violenza della donna in quanto reazione ad una violenza invece ingiustificabile operata dai due giovani. Per certi versi, con tale sequenza, il pubblico
«viene attirato nell’orbita di violenza alla quale si illudeva, attraverso la condanna dei personaggi, di rimanere estraneo. Provando sollievo e soddisfazione per il modo con cui la moglie si sbarazza del ragazzo, egli smette di rinnegare la violenza in quanto tale, proprio perché in quel punto assume verso di essa un atteggiamento di approvazione e complicità (…) lo spettatore sin lì crede di poter uscire dal film confortato nella sua convinzione che la violenza è comunque odiosa e sbagliata, mentre in realtà, a causa di quella scena, dovrà uscirne con la convinzione che la violenza può essere sbagliata oppure legittima, a seconda delle circostanze morali che la preparano e motivano. Nello stesso tempo quel frammento – riavvolto con suprema disinvoltura in virtù di un telecomando – ci dice anche che la violenza del cinema, per quanto possa suscitare in noi sentimenti di adesione ai personaggi che la subiscono e di avversione per quelli che la infliggono, è volatile, inconsistente e relativa».
La violenza naturale
Come abbiamo visto, nel cinema narrativo convenzionale si dà per scontato che la violenza sia espressione di malvagi sistematicamente sconfitti dai coraggiosi difensori dell’Ordine e della Legge. L’Eroe è violento ma è costretto a questa violenza dalla sua missione; è questo il senso della famosa licenza di uccidere di James Bond. Al contrario in alcuni film i cineasti assumono uno sguardo puro, per così dire “a-morale”. È emblematico il caso di Assassini Nati di Oliver Stone. La violenza è qui mostrata in tutta la sua sfacciata esuberanza, senza la necessità di addurre motivi o giustificazioni.
Girato alternativamente a colori e in bianco e nero e impiegando diversi formati di pellicola (35 e 16 mm, super 8 e video) la violenza sembra emergere dalla stessa vertiginosità delle immagini, dalle malsane inquadrature di sbieco della macchina da presa, nonché dalle deformazioni, dagli stacchi, dalle sovrapposizioni. Pura violenza dell’immagine, anzi dello specifico filmico da e pura violenza dell’uomo: dunque violenza della e “nella” immagine. Nel film di continuo appaiono sequenze sovrapposte di insetti o di animali più grandi intenti a divorarsi l’un l’altro o a intrattenere distruttivi rapporti sessuali. La baldanza di questa violenza “naturale” fine a sé stessa è resa già esplicita dal titolo del film “assassini nati”, e questo motivo viene compiutamente sviluppato nel momento più importante del film quando il protagonista Mikey (Woody Harrelson), interrogato in carcere dalla polizia ,dice che lui e la sua violenta moglie Mallory Knox (Juliette Lewis) uccidono come fanno né più né meno tutti gli altri esseri viventi che si divorano continuamente a vicenda.
Precedentemente un vecchio indio che finiscono per uccidere per sbaglio aveva raccontato loro una storia in cui una donna salva la vita a un serpente che, una volta ripresosi, uccide la sua salvatrice mordendola a una guancia; interrogato in merito dalla donna morente si lmita a rispondere: «Stupida cagna, non sapevi che ero un serpente?». La tesi è esplicitamente antimorale o, meglio, è la natura che sembra escludere radicalmente la moralità, senza metterla in discussione né rifiutarla, piuttosto ignorandola completamente a livello di concetto.
La violenza recondita
Cane di paglia di Sam Peckinpah racconta di un matematico americano (Dustin Hoffmann) che si trasferisce in un paesino della campagna inglese per dedicarsi al suo lavoro. Da subito è vittima di scherno e angherie da parte degli abitanti del posto, Un gruppo di giovani, che il matematico aveva precedentemente chiamato in casa a fare dei lavori, arriva addirittura a stuprare la sua giovane moglie. Lei si chiude nell’omertà e non dice niente al marito ma lo scontro con gli abitanti del luogo è vicino. Quando questi, ubriachi, tentano di assaltare la sua casa per linciare un uomo con problemi psichici, allora il mite e pacifico matematico si trasforma in un genio del massacro. Il “cane di paglia” del titolo è il protagonista, il matematico immerso nei suoi calcoli superiori, e che trova in sua moglie Amy, una vera e propria “bambola di carne”, lo spazio in cui liberare i propri impulsi sessuali. Affinché esplodano anche la sua violenza e la sua ferocia bisognerà attendere il finale. Egli passerà dall’insipida passività, che lo ha caratterizzato sino a quel momento, alla fredda e spietata perfezione omicida.
Cane di paglia pone due scottanti questioni, fondamentali per il regista, ma destinate a rimanere senza soluzione: egli si chiede se ogni rapporto tra uomo e uomo non si risolva in un rapporto di sopraffazione, in cui vanno distinti un dominante e un dominato, e se ogni rapporto tra uomo e donna non adombri la violenza sessuale. E’ questa la domanda che Peckinpah, senza tanti fronzoli, pone allo spettatore nella tagliatissima scena di in cui viene mostrato l’amplesso/stupro.
A tre quarti circa del film, il protagonista viene invitato ad una battuta di caccia dai giovani operai abitanti del luogo. Ma è solo una scusa per allontanare l’uomo da casa, dove ha lasciato, sola, Amy. Uno dei giovani, il rude Charlie, con cui Amy aveva avuto in passato un piccolo flirt, si introduce in casa con l’intenzione di approfittare della donna. Quest’ultima, dopo un’iniziale opposizione, sembra assecondare Charlie, con il quale finisce per fare sesso. Arriva poi un amico dell’uomo, Scott, che reclama anche lui la sua parte nonostante la reazione di Charlie, ed è solo allora che la situazione prende decisamente la piega di un effettivo stupro, culminante in un atto di sodomìa In Cane di paglia, dunque, Peckinpah si chiede se la società contemporanea non risponda ancora, nel profondo, a dinamiche di tipo tribale.

Peckinpah, da spregiudicato studioso dell’uomo e delle sue relazioni, vuole indagare e mostrare gli effetti devastanti della violenza sulla vita dei personaggi e sui loro sentimenti. La violenza impregna ogni fotogramma del regista di Fresno e non lascia scampo ai protagonisti delle sue storie. Quello di Peckinpah non può essere un cinema pacifista come alcuni benpensanti sembrano pretendere perché, seppure il regista sia del tutto consapevole che la violenza non è ciò che fa di un individuo un uomo, egli d’altra parte sa e ci vuole mostrare, senza veli né patinature, che se la violenza arriva non le si può sfuggire e si è costretti, in qualche modo, a prendervi parte.
Il cinema di Peckinpah rimane soprattutto un’inarrestabile discesa negli abissi della natura umana, una vera e propria ricerca di natura antropologica, psicologica e sociologica sulle condizioni che scatenano l’animalità insita nell’uomo. Il regista, come uno scienziato in laboratorio, immerge i suoi personaggi/cavie in determinati contesti e attende le loro reazioni per studiarle e descriverle, con intelligenza ed onestà intellettuale, senza omettere nulla, senza paura. E’ il timore di penetrare la vera natura dell’uomo che Peckinpah condanna con fermezza e che egli addebita alla morale borghese e ai nuovi mezzi di rappresentazione e autorappresentazione della società, tv e pubblicità in primis. Il regista stesso dichiarò «Quando la gente impreca contro il mio modo di trattare la violenza in pratica dice “non mostratemela, non voglio sapere…”, credo che sia sbagliato e pericoloso rifiutare di riconoscere la natura animale dell’uomo».









