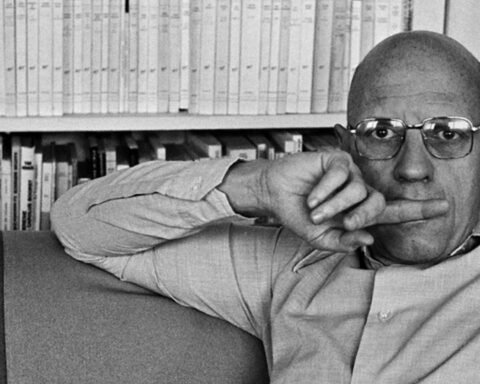Furono in molti gli studenti che cinquant’anni fa a quest’ora tenevano in mano, o leggevano, L’uomo a una dimensione di Herbert Marcuse, spietato ritratto di una società che, a quanto si diceva, era tempo di cambiare. Il libro, uscito nel 1964 in Usa (in Usa: perché Marcuse, filosofo ebreo nato in Germania, dovette emigrare dall’Europa verso il Nuovo Mondo causa persecuzioni naziste) vide le stampe nel Vecchio Continente qualche anno dopo. Era ciò di cui il ’68 aveva bisogno.

Marcuse e la Scuola di Francoforte
Un cenno brevissimo su Herbert Marcuse: la sua opera va inquadrata nell’ambito della cosiddetta Scuola di Francoforte, indirizzo di pensiero inaugurato all’inizio degli anni ’20 da Theodore Adorno e Max Horkheimer. Anch’essi, Adorno ed Horkheimer, costretti dalla guerra ad attraversare l’Oceano, per poi ritornare in patria a conflitto terminato. La specialità della Scuola di Francoforte, e il motivo per cui li ricordiamo? In due parole: Teoria Critica. Teoria Critica, ovvero un modo di guardare al mondo, alla società agli uomini, fortemente influenzato da marxismo e psicanalisi freudiana, la cui pretesa era dissotterrare le radici ideologiche che soggiacevano alle false libertà della cultura, della politica, dell’esistenza umana celebrata in Europa ed America. Uno sguardo critico, ossia che spezza in due, ciò che l’opinione è solita accettare, per mostrarne il marciume sottostante.
L’uomo a una dimensione
Lo stesso fa L’uomo a una dimensione (acquista), che si apre con una frase, famosissima, che è un pugno nello stomaco. «Una confortevole, levigata, ragionevole, democratica non-libertà prevale nella civilità industriale avanzata, segno di progresso teorico». Qui, tutto il libro. L’unidimensionalità di cui ci parla Herbert Marcuse non è altro che la levigata non-libertà che, come una bolla, cresce, cresce, cresce, al ritmo del progresso industriale.
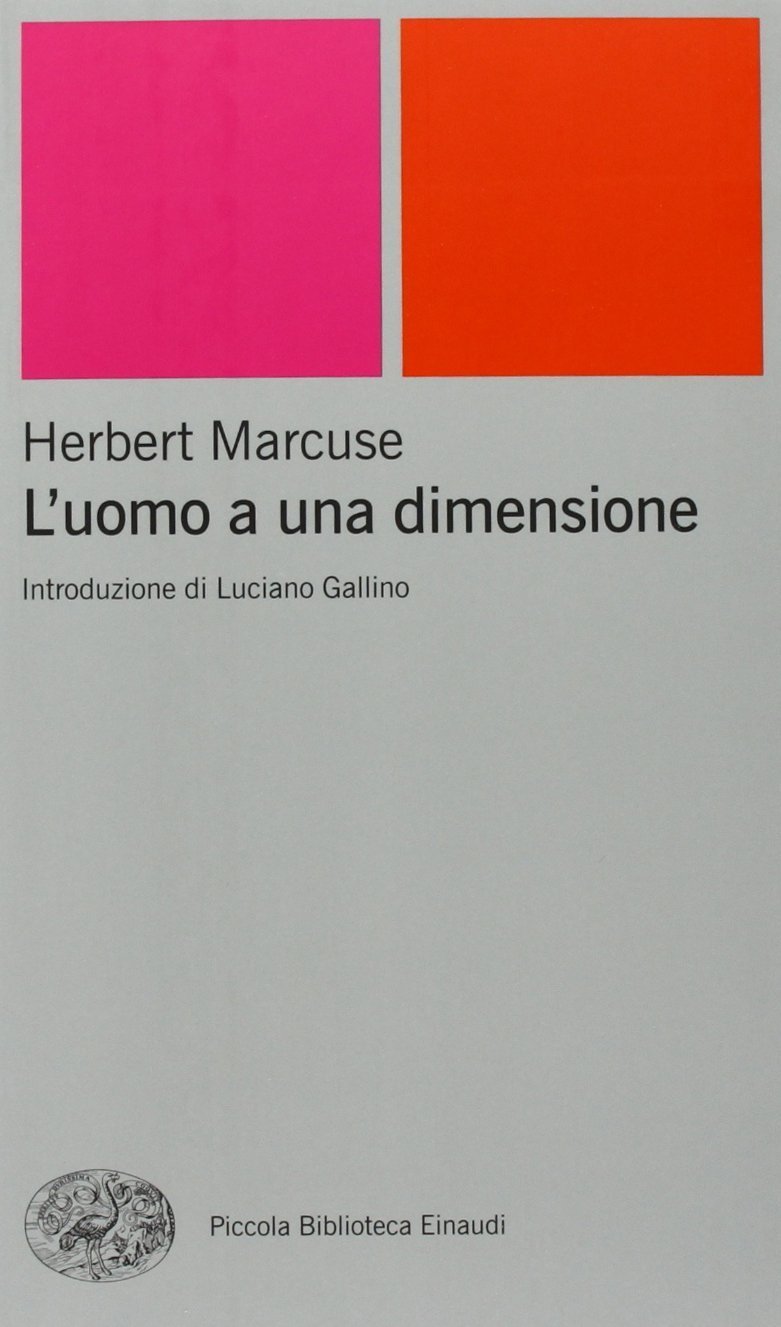
Difatti, è alla “società industriale avanzata” che Marcuse rivolge le sue critiche, ossia, comunista o capitalista che sia, alla società che fa dell’industrializzazione il motore del suo sviluppo, che trasforma l’uomo in mezzo, cioè lavoratore, posto di fronte ad un unico fine: il progresso industriale. La natura è quantificata, tutto diviene misurabile – persino la filosofia, che secondo Herbert Marcuse ha il suo corrispettivo nella corrente del Positivismo. Insomma, una società talmente onnicomprensiva da rendersi invisibile. Per questo è confortevole: semplicemente non si vede. E chi ci vive, ne respira l’aria marcia, ma ci si abitua, tanto che la stessa società industriale rende la servitù di cui l’uomo è al contempo vittima ed artefice, «benaccetta e forse anche inosservata». Spieghiamoci meglio.
Annullamento dell’opposizione
La questione filosofica che soggiace all’analisi marcusiana è interessante: Marcuse utilizza categorie filosofiche hegeliane per sintetizzare l’unidimensionalità di cui l’uomo della società industriale sarebbe vittima mansueta. E già della parola unidimensionalità troviamo il nodo del pensiero di Herbert Marcuse. Ciò che fa l’unidimensionalità è annullare, o meglio, inglobare, quello che Hegel chiamava il Negativo: l’elemento sovversivo che costituisce ogni rapporto sociale. Il proletario si dà in virtù della sua opposizione alla borghesia, come diceva Marx, che di Hegel fu uno dei lettori più intelligenti. Un’opposizione simile polverizzata dalla società, e ricostituita ad un altro livello, fittizio.
Leggi anche:
Karl Marx e la filosofia che si fa prassi rivoluzionaria
Cultura unidimensionale
Nella società industriale avanzata, il Negativo, il Nemico – dice Herbert Marcuse – ossia la forza che mette a rischio la società stessa, è annullata, inglobata dal sistema stesso. Ecco il pensiero unico. L’opposizione è appiattita. Ciò non vale esclusivamente per le parti politiche in gioco, dimodoché qualsivoglia bipolarità si ritrovi annullata nella società, mascherata da nomi come destra e sinistra. Non solo le parti politiche, si diceva, ma anche, ad esempio per la cultura.
Nella società industriale avanzata, il ruolo sovversivo della cultura cade. La cultura è integrata così a fondo, da divenire schiava della società. Dice Marcuse: «la realtà supera la cultura». La forza sovversiva della cultura, il suo carattere potenzialmente esplosivo, la sua capacità di trascendere, cioè mettere in discussione il senso comune, l’esistenza quotidiana, perde di vigore, si affloscia. Non è più possibile il processo di alienazione artistica, ossia di trascendenza consapevole da parte delle arti, del teatro, della letteratura, dell’esistenza alienata. La cultura non è più un’altra dimensione – in termini hegeliani, non è più un momento del Negativo.

In parole povere, la cultura diviene merce: la legge già indicata da Marx anni addietro, si realizza nella società industriale avanzata, dove il circolo denaro-merce-denaro è esteso all’intero ambito dell’esistente. Ma, essendo l’oggetto, la cosa, semplice surrogato del suo valore di mercato, la mercificazione diviene totale. Di nuovo, unidimensionalità. «Le opere nate dalla condizione alienata sono incorporate in questa società e circolano come parte integrante dell’attrezzatura che adorna lo stato di cose precedente». Comprando tutto, tutto è possibile, e la permissività si maschera della libertà che l’uomo ad una dimensione crede di possedere. Ma non è così, egli non è libero, e vincolato piuttosto ad un freno inconscio. L’uomo non è più capace di sublimare, ossia, egli «può compiere oggi cose più grandi che non gli eroi e i semidei della cultura;».
In virtù del progresso, e della mercificazione, tutto è in suo potere – ma è un’illusione, perché non sono i suoi bisogni primari ad essere soddisfatti, quanto piuttosto l’inessenziale superficialità dei bisogni imposti dal sistema stesso. Una bella macchina, una bella casa, un bell’orologio dipingono l’ideale della libertà nella società industriale avanzata, ma mascherano ciò che manca davvero: lo spazio per scegliere, lo spazio per la critica.
Herbert Marcuse, oggi
Francamente, è difficile dire cosa sia vivo e cosa sia morto dell’analisi marcusiana. Certo è che molti dei noti de L’uomo a una dimensione rimangono vincolati al tempo e al luogo in cui fu scritto, ossia 50 anni fa in America, nei favolosi anni ’60, gli anni di Hollywood, di Topolino «filosofo del fare», come è stato recentemente definito, del suicidio di Marilyn, ma anche della guerra in Vietnam, e di Muhammed Alì che rifiutava di andarci. Anni di grandi contraddizioni, anni in cui, come riporta Marcuse sui giornali si trovavano annunci pubblicitari di rifugi antiatomici con salotto e cucina. Insomma, anni destabilizzanti.
L’analisi marcusiana oltre ad indicare alcuni interessanti elementi di verità nel campo della cultura (è innegabile che la letteratura contemporanea realizzi pienamente quanto già vedeva Herbert Marcuse per il romanzo degli anni ’60: uno stravolgimento dell meccanismo di sublimazione, tale per cui qualsiasi oggetto viene de-erotizzato in virtù della sua disponibilità; si pensi ai romanzi di Philip Roth, di Charles Bukowski, ma anche della Beat Generation, di David Foster Wallace); oltre a ciò, dicevamo, ci ricorda un’eterna verità. Imparare a smascherare i permessivismi trasformati in libertà dal sistema, riconoscere la puzza da bruciato e guardare ciò che sta sotto. Insomma, scoperchiare i falsi dogmi della quotidianità, e risvegliare la coscienza ai suoi veri diritti. Il problema è farlo, e sopratutto esser consapevoli di star facendolo; altrimenti si ricade nell’unidimensionalità. Chi sono, dunque, i nostri Herbert Marcuse?