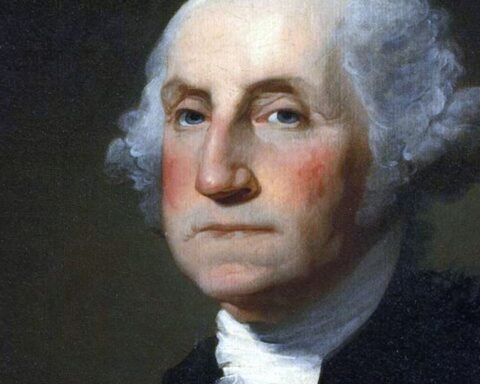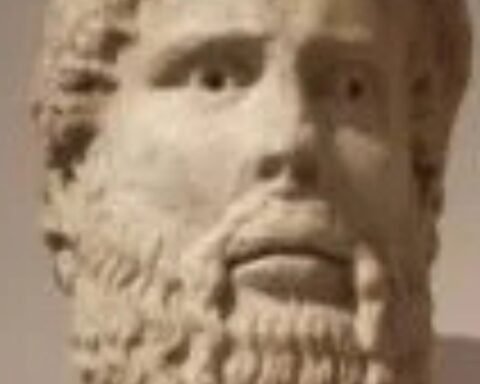Quando si spense, nel 1924, Gabriele D’Annunzio scrisse di lei: «È morta quella che non meritai». E di lei il vate conservò per sempre un busto di marmo al Vittoriale. Ma Eleonora Duse, sulla scena soprannominata “La Divina”, attrice famosissima, pioniera dell’affermazione femminile del Novecento, è stata molto di più che l’amata del poeta. La sua brillante carriera artistica, di portata mondiale, attirò l’interesse storico per un personaggio non marginale; una donna che quando conobbe D’Annunzio era più famosa di lui.
Nata a Vigevano, nel 1858, morta negli States, a Pittsburgh, nel 1924, portò in scena, nei teatri italiani ed esteri, alcuni tra i più noti personaggi femminili, comici e tragici. Un grande pathos, un grande senso della catarsi attraverso la recitazione, una grande empatia con le figure che portava in scena. La sua bravura, i suoi tratti peculiari e la sua espressività le hanno consentito di raggiungere un tale livello di fama e di apprezzamento pari, nell’universo maschile, a quella raggiunta da Rodolfo Valentino: un’icona assoluta.
Le donne delle mie commedie mi sono talmente entrate nel cuore e nella testa che mentre m’ingegno di farle capire a quelli che m’ascoltano, sono esse che hanno finito per confortare me.
Eleonora Duse riferendosi ai suoi personaggi
La carriera, il teatro, i personaggi di Eleonora Duse
Come detto, Eleonora Duse portò in scena noti personaggi teatrali. Recitò anche per Luigi Pirandello, riportando sulle scene la celebre Mirandolina, la locandiera di goldoniana memoria, abile ad ingannare tutti i suoi pretendenti, i viandanti che passavano per la sua osteria, beffandosene con astuzia. Il suo esordio risale addirittura agli anni Sessanta dell’Ottocento, quando a soli 4 anni d’età recitò in una rappresentazione de I Miserabili, di Victor Hugo.
Recitò anche per rappresentazioni tratte dalle opere di Giovanni Verga, come Cavalleria rusticana. E ancora, fu protagonista della messa in scena di Antonio e Cleopatra, adattata per lei dal musicista Arrigo Boito. Divenne così famosa che, nel 1898, il teatro Brunetti di Bologna venne ribattezzato Teatro Duse.
Leggi anche:
Le passioni e il tormento di Gabriele D’Annunzio
Nel 1881 Eleonora aveva già sposato Tebaldo Marchetti, anche lui attore di teatro, dal quale però si separò definitivamente. Nel frattempo la Duse recitava in Italia e all’estero, anche in Sudamerica. Alla Duse si sarebbe ispirato anche Konstantin Stanislavskij – come lui stesso affermò – per la creazione del Teatro d’arte di Mosca, in Russia. Ad darle il soprannome di “Divina” sarà poi Gabriele D’Annunzio; soprannome che però le resterà e sarà utilizzato anche dal grande pubblico di teatro.
Il 30 luglio 1923 la copertina della rivista Time, allora ancora agli albori, fu dedicata ad Eleonora Duse: fu la prima donna – e italiana – ad avere questo spazio sulla nota rivista, ma non fu l’unico primato della “Divina”. L’attrice, infatti, fu probabilmente la prima nel suo campo a comparire in una pellicola cinematografica. Fu il film Cenere (1916), diretto da Febo Mari, ispirato all’omonimo romanzo di Grazia Deledda, penna notissima della letteratura italiana del Novecento. La stessa Eleonora Duse si propose per interpretare il ruolo. Si tratta dell’unica apparizione della Duse su pellicola.
La storia d’amore con D’Annunzio e il romanzo «Il fuoco»
L’incontro tra Eleonora Duse e Gabriele D’Annunzio avvenne nel 1882. La Duse aveva divorziato dal marito l’anno prima. La “Divina” era a Roma, per recitare ne La signora delle camelie e D’Annunzio rimase affascinato dalla vista dell’attrice, cercando di conoscerla nei camerini. La storia con il vate è caratterizzata dal fatto che all’inizio – così pare – la Duse non fosse minimamente interessata a lui, al giovane poeta d’Abruzzo, che ancora non era famoso, ma soprattutto non lo era quanto lei. Inoltre, Eleonora era più grande di D’Annunzio di cinque anni.
Leggi anche:
Angeli e cortigiane, le donne nel teatro dell’Ottocento
C’è chi ha interpretato il corteggiamento da parte di D’Annunzio nei confronti della Duse anche come un modo per guadagnare, attraverso lei, visibilità e maggiore fama. Eleonora Duse, come detto, era famosissima, al tempo più di lui. Inoltre avrebbe potuto aprirgli le porte di quel regno dell’arte non ancora sondato dal poeta: il teatro, verso il quale si avvierà di lì a poco.
Il corteggiamento durò parecchio. All’attrice il poeta regalò una copia delle Elegie romane, la sua raccolta poetica, con tanto di dedica. Fu poi lei a volerlo conoscere, a volerlo rincontrare. Ne nascerà una storia d’amore durata circa un decennio, interrotta poi da un graduale allontanamento, dettato soprattutto dalle continue partenze della Duse per le sue tournee in giro per il mondo. L’ultima delle quali negli Stati Uniti dove morirà, nel 1924, di polmonite.
A Eleonora il poeta dedica uno dei suoi più celebri romanzi: Il fuoco (1900), di ambientazione veneziana, facente parte della trilogia I romanzi del melograno. L’opera appare come una vera e propria trasposizione letteraria e romanzata della storia d’amore tra l’autore e la Duse. Stelio, il protagonista, amante dell’arte e della bellezza, alla continua ricerca della passione e dell’ispirazione, perso tra le strade e i palazzi di Venezia e affascinato dalle melodie di Wagner (che morirà in effetti a Venezia in quegli anni), nutre un amore sconfinato per la Foscarina, attrice poliedrica, più grande di lui e sempre in viaggio per il mondo.
La storia tra i due si conclude, come nella vita reale, con un allontanamento. La Foscarina riparte per scoprire il mondo e lascia Stelio a Venezia, secondo il romanzo per lasciarlo libero di inseguire l’arte e la bellezza in tutte le sue forme, con la consapevolezza di aver creato però un amore più forte di qualunque altro. Da un poeta fortemente legato all’Estetismo e al Decadentismo come D’Annunzio, la trama, associata alla città dell’amore e della bellezza per eccellenza, Venezia, non può che calzare a pennello.
La pioggia nel pineto: Ermione è Eleonora Duse
Piove su i nostri vólti
silvani,
piove su le nostre mani
ignude,su i nostri vestimenti
leggieri,
su i freschi pensieri
che l’anima schiude
novella,
su la favola bella
che ieri
t’illuse, che oggi m’illude,
o Ermione.
Nella celebre poesia La pioggia nel pineto di Gabriele D’Annunzio, simbolo della sua volontà poetica di totale immersione nella natura, di totale fusione con la natura, quasi un vero manifesto del Panismo, la fanciulla che con lui si bagna tra i boschi, durante un temporale, è chiamata dal poeta Ermione. Non è che un nome di comodo, riferito in realtà proprio a Eleonora Duse, che al tempo della composizione intratteneva la relazione con il vate. La poesia fa parte di quella che forse è la più bella raccolta delle Laudi, cioè Alcyone.
Leggi anche:
L’arte e le domande della modernità
I funerali, la sepoltura, il culto al Vittoriale
Pare che fu lo stesso D’Annunzio a scrivere a Mussolini per far riportare in patria la salma di Eleonora Duse dagli Stati Uniti. Il feretro arrivò su una nave, salutata dal suono delle altre imbarcazioni all’arrivo in Italia. Alla Duse furono dedicati veri e propri funerali di Stato e la salma fu poi seppellita, come da lei chiesto, nel cimitero di Sant’Anna ad Asolo, col volto in direzione del Monte Grappa, luogo della memoria dei soldati italiani caduti.
D’Annunzio coltiverà negli anni successivi un vero e proprio culto per il busto della Duse conservato al Vittoriale. Già durante la Prima Guerra Mondiale il poeta aveva sempre portato con sé, incastonati in un anello, due diamanti donatigli da Eleonora Duse. Li considerava un amuleto in grado di proteggerlo dalla morte in battaglia.

Non abbiamo grandi editori alle spalle. Gli unici nostri padroni sono i lettori. Sostieni la cultura giovane, libera e indipendente: iscriviti al FR Club!
Segui Frammenti Rivista anche su Facebook e Instagram, e iscriviti alla nostra newsletter!