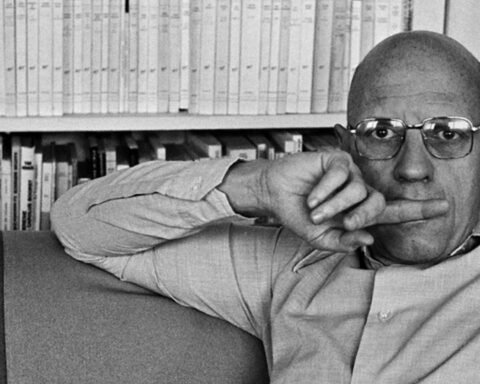Chi l’ha detto che l’alienazione è una bestiaccia, una piaga, un brutto mostro? Ma certo, caro Carlo Marx, certo che l’hai detto tu; mica ci si è dimenticati delle tue urla, delle tue corse per l’Europa a sabotare, con pagine e pagine di fatica, il sistema del Capitale, padre dell’alienazione, crocifisso dell’umanità. Ma concedi ora qualche minutino per chiosare la fiamma dei tuoi scritti, smorzarla e spegnerla, se necessario, di modo che noi si possa nuovamente accogliere a braccia aperte la nostra cara vecchia amica – da te relegata nel mondo dell’infamia – Alienazione.
È chiaro: con il lavoro disumano, che rende l’uomo un animale, il lavoro che costringe ad amare ciò che altrimenti, per natura, questi detesterebbe – ecco, con ciò noi non abbiamo nulla da spartire. Ed anzi, Marx, lo ringraziamo per aver reso la storia un po’ più sensibile al problema delle quote salariali e degli orari ridotti. Questa è certo roba brutta, da condannare, che toglie all’uomo la sua più autentica umanità. Ma che dire della dose di alienazione che, invece, sa risanare portando aria nuova nelle vite addormentate? Dovremmo pur tenercela stretta, quantomeno se non cerchiamo la follia o la disperazione.
Già Platone, in fondo, lo diceva. Che l’amore sia la condizione dell’alienato, dell’invasato, del poeta che guarda il mondo con entusiasmo (en-thèos, aver dentro sé il dio), che l’amore sia questo è chiaro ad ogni innamorato. Ritrovare se stessi nell’altro, nell’occhio dell’altro, e perdervisi in un abbraccio di unità, non è questo, forse, alienazione? Concludeva poi, Platone, che è propria dell’innamorato la forma più pura di conoscenza, quella appunto che aliena e concede di guardare le cose senza mediazioni, che trasforma lo sguardo in puro occhio sul mondo. Così, è piuttosto il cammino che conduce all’uscita da sé che duole, che brucia come il dente che spinge sotto la gengiva o come le ali che premono sulla scapola. Ma poi, il filosofo, libero dal dolore, eccolo che vive nella felicità del diventare ombra, lasciandosi dietro il corpo, dimenticandosi di dire «Io».
Leggi anche:
«La fine di tutte le cose», ovvero l’inizio della filosofia
L’alienazione, lungi dall’essere una bestiaccia, è la medicina dello spirito e la quiete di una vita costretta nella parola Io. Non è immaginabile un’esistenza rigorosamente condotta sui binari dell’identità, un’esistenza sottratta alle sane dosi di estasi che la vita talvolta concede. Guardiamone qualcuna. La lettura, ad esempio. Leggere è di certo una forma perfetta di alienazione; anzi, leggere obbliga il lettore ad alienarsi. Ci si pensi. Tu, lettore, forse ti domandi cosa, come, quando e perché mentre stai leggendo? Forse proietti il tuo ego fra le parole che qui vedi scritte per, come dire, usarle a mo’ di specchio? Certo, lo fai dopo. Ma, nel mentre, leggi e basta; anzi – lasci che lo scritto in qualche modo si imponga. Si è immersi nella lettura – e non c’è altro, non c’è il brusio dell’Io che richiama alla coscienza. Un po’ di pace.
Un’altra prova ce la regala Wittgenstein. Sappiamo di lui che, terminate le lezioni ordinarie a Cambridge, amava correre al cinema e sedersi in prima fila a godersi la proiezione del giorno. Diceva che la prima fila gli permetteva di occupare, con lo schermo, l’intero campo visivo, senz’aver altro davanti agli occhi. Chiamarlo non si poteva, non avrebbe risposto. Si trasportava interamente fuori dal mondo della logica per ritrovare il fiato nei colori (bianco e nero, all’epoca) delle immagini sul telo. E lo stesso lo sentiamo tutti noi quando, finito un bello spettacolo, ci ritroviamo come un po’ spiazzati e tristi, manchevoli di quel coinvolgimento che ci aveva così bene sottratto a noi stessi. È vero, no?
Carmelo Bene rifaceva l’Amleto inserendovi i versi di Gozzano, ed urlava «io non voglio più essere io»; ad essere di continuo se stessi si esce di testa: dolore e sofferenza sono la cifra dell’individualità, il richiamo costante che ci obbliga a non dimenticarci di noi. Niente di più individualizzante del dolore, niente di più doloroso dell’io. A salvarci è l’alienazione, il raro subentrare dell’alterità nella vita sotto una teca di cristallo, la teca dell’io. D’altronde, questo l’aveva capito anche Borges, quando, chiedendosi che cosa fosse il tempo, riconosceva in esso la gabbia dell’identità. E concludeva uno dei suoi saggi più famosi, con parole ciniche, ma vere:
Il tempo è la sostanza di cui sono fatto. Il tempo è un fiume che mi trascina, e io sono il fiume; è una tigre che mi sbrana, ma io sono la tigre; è un fuoco che mi divora, ma io sono il fuoco. Il mondo, disgraziatamente, è reale; io, disgraziatamente, sono Borges.
Non abbiamo grandi editori alle spalle. Gli unici nostri padroni sono i lettori. Sostieni la cultura giovane, libera e indipendente: iscriviti al FR Club!
Segui Frammenti Rivista anche su Facebook e Instagram, e iscriviti alla nostra newsletter!