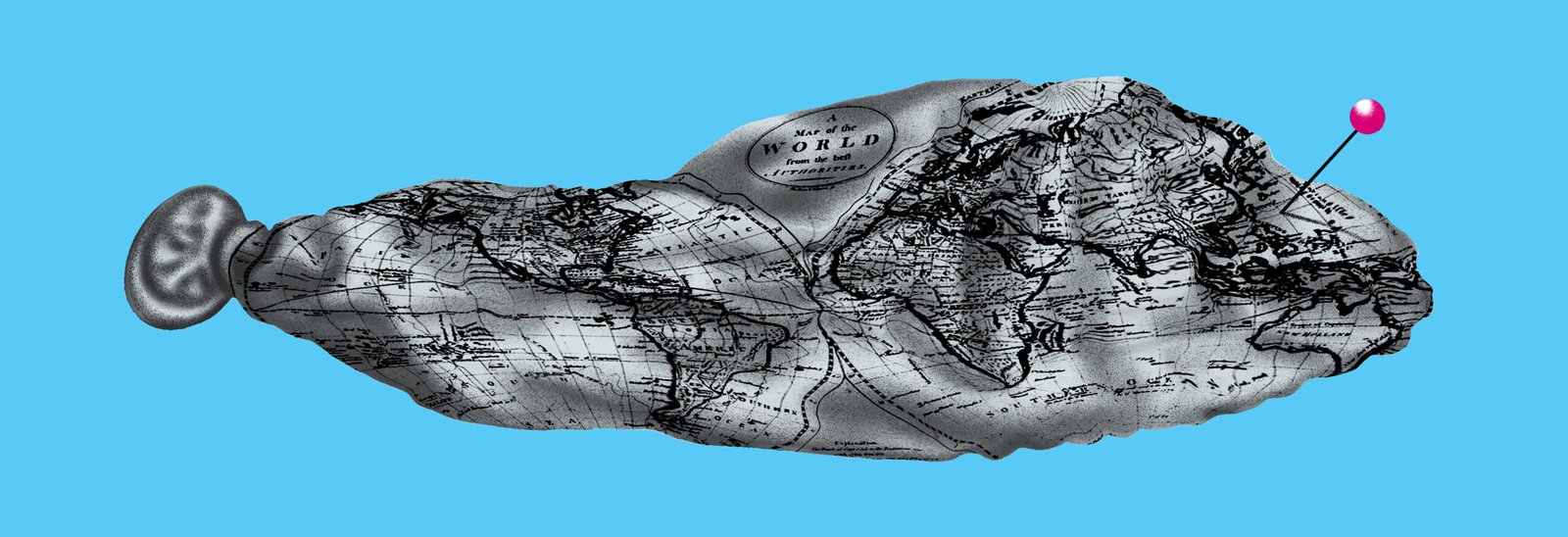La fine del mondo, oggi, si prospetta imminente, il collasso vicino – ma che mondo sta per finire? E quale mondo vogliamo non finisca?
Il problema della fine del mondo ossessiona i grandi monoteismi sin dal loro primo sorgere, gli è, in qualche modo, connaturato, come ad indicare che solo se vista dalla prospettiva del suo termine la vicenda umana può acquisire il proprio senso. Tutte le religioni, ci dice lo storico medievale Jean Flori, «insegnano che questo mondo creato non è eterno: ha avuto un inizio, avrà quindi anche una fine»; pensiero, quest’ultimo, che rappresenta l’esatto opposto di quanto invece sosteneva, Aristotele, maestro di color che sanno, per il quale proprio perché il mondo è eterno, esso non poté aver inizio, così come non potrà finire.
In questo contesto, che si prolunga tutt’ora sotto forme variamente eterogenee, la caccia alla data esatta doveva rivelarsi la prerogativa dei profeti, e con loro di chi indicava nella redenzione del peccato l’obbligo più urgente in vista di un passaggio ad un post, il cui volto rimaneva ancora coperto dal mistero. Apocalisse, in greco, è questo: rivelazione, rivelazione di quel volto, rivelazione del momento nel quale la storia si raccoglie entro la dimensione di un presente infinito, un’esplosione di luce che fissa nell’eternità l’albedo dei secoli trascorsi. Si dice essa venga accompagnata da un suono di trombe. Le simbologie numeriche attinte dalle più diverse tradizioni si piegano di volta in volta alla necessità del presente: non centrano mai il tempo preciso, ma segnalano l’ansia di un evento che dovrà accadere. Il libro di Daniele e l’Apocalisse di Giovanni diventano, nel Medioevo, il filtro da rimodulare per individuare il punto preciso del termine della storia.
Paura, reverenza, terrore. Henri Focillon ha notato, nei suoi studi sull’Anno Mille, che la misura cronologica che chiamiamo “anno” può divenire l’involucro di un tempo capace di addensarsi; il tempo dell’aspettazione condensa il passaggio di una serie di eventi che scorrerebbe altrimenti rapida. La cifra di un’epoca che attende la propria fine è quella della crisi, della frattura che squarcia l’incedere pacato e lineare del tempo, lasciando intravedere nel suo framezzo i segni che preannunciano la rivelazione. Il tempo, come un magma, si coagula, si addensa: non passa, o lo fa lentamente – ed è questo incedere angosciante che prelude alla fine.
Sono fantasie? Sono i fantasmi di un’epoca, il Medioevo, ancora incapace di pensare? No, pare di no. Gli sconvolgimenti che hanno reso così disastrosamente intenso l’anno che stiamo vivendo – questo nostro 2020 – riaccendono in noi la paura della fine, il timore della catastrofe.
Leggi anche:
Sulla natura
Aristotele ricordava nella sua Poetica che il momento culminante dello svolgimento della narrazione tragica è proprio quello catastrofico, là dove il rovesciamento narratologico (come quando Edipo scopre di essere parricida incestuoso) raggiunge la sua acme nella catarsi purificatrice dell’animo dello spettatore. Lo stesso accade oggi: ciò che abbiamo davanti, tuttavia, non è la vicenda straziante di un uomo che ignora la propria colpevolezza, ma quella di un mondo che si dimostra vivo, e non morto, come per molto tempo avevamo voluto credere. La fine del mondo inaugurata dalla modernità, come l’ha definita lo storico francese Jean-Baptiste Fressoz, è “gioiosa”: frutto di decisioni guidate dal miraggio del progresso, che ora si riverberano, come di rimbalzo, su chi le ha compiute – l’uomo. La fine del mondo ritrova così anche i suoi profeti tra chi preannuncia l’avvento di una nuova era, l’Antropocene, che avrebbe già compromesso le magnifiche sorti dell’uomo su questa terra, chi vede nella catastrofe climatica l’imminente inizio della fine, chi, sull’onda lunga delle vittime mietute nel secolo passato, indica nell’energia nucleare la fine di tutte le cose. L’epidemia: ecco infine l’ultimo segno che convalida quanto già annunciato nei testi sacri.
Leggi anche:
Cinque saggi da leggere su natura, ecologia e filosofia
Che fare? Sembra che l’unica soluzione, se la fine del mondo è davvero imminente, sia incrociare le braccia per rassegnarsi in una comoda passività. Già Leopardi trovava nel Cantico del gallo silvestre la consolazione per i dolori dell’esistenza nella consapevolezza di un’inevitabile conclusione del mondo. Uno scoppio immenso, un battito di ciglia e il dileguarsi dell’uomo lasciano spazio ad una quiete altissima, al silenzio del vuoto: «Così questo arcano mirabile e spaventoso dell’esistenza universale, innanzi di essere dichiarato né inteso, si dileguerà e perderassi». L’inettitudine è una soluzione, certo: l’immagine di un mondo che finisce, profetata da ecologisti e scienziati climatici, da attivisti e pacifisti, apre la via all’inoperosità.
C’è, però, un’altra strada che si può battere. Il grande antropologo napoletano Ernesto de Martino ha dedicato un’opera (incompiuta, recentemente ripubblicata in una nuova veste editoriale) al problema della fine del mondo. La tesi di de Martino è che ogni cultura esperisce il sentore della propria fine nella forma di un rischio che fa vacillare la continuazione della sua esistenza. L’introduzione del nuovo (ad esempio, della tecnologia per diverse società dell’Africa centrale), il profilarsi di imminenti scenari catastrofici (ad esempio, la catastrofe climatica), eventi che sconvolgono il senso comune (ad esempio, l’attentato terroristico) non preludono, secondo de Martino, alla fine del mondo tout court, all’apocalisse, ma alla possibilità di integrare – e cioè dare un significato – entro la propria cultura a quello che si palesa come l’espressione dell’assurdo, del non senso. La fine del mondo, in questi termini, è la possibilità distruttrice che attenta a ciò che de Martino chiama la “presenza”: l’umana facoltà di agire nella storia, l’orizzonte di operatività che rende uomo l’uomo. L’apocalisse è la crisi della presenza, la possibilità, non ancora inquadrata in un ambito di significato, che una cultura finisca. Di qui l’appello all’azione, per il tramite dell’intervento culturale. È solo nella cultura che la fine del mondo può venir esorcizzata; è solo nella cultura che si può scegliere come non lasciare che il mondo finisca; è solo nella cultura che ciò che attenta alla sua sopravvivenza trova significato, per essere incluso in essa.
Leggi anche:
Sguardi filosofici a «La peste» di Albert Camus
Che il mondo possa, ma non debba, finire deve accompagnarci come una fede perpetua, una fede ogni volta superata dall’equilibrio ristabilito per mezzo della e nella cultura. La fine del mondo, oggi, si prospetta imminente, il collasso vicino – ma che mondo sta per finire? E quale mondo vogliamo non finisca? Non si tratta, lungi dall’essere la prefigurazione angosciante di un vicolo cieco per la storia dell’umanità, dell’occasione per ripensare tutto ciò che fino ad ora è stato fatto, creato, costruito, distrutto? Pare questa volta l’occhio all’orizzonte debba esser tenuto ben fisso; ancora e sempre di nuovo il confine della storia ci chiama a raccolta, e ci avverte: hic sunt leones.
In copertina: Artwork by Tatanka Journal
© Riproduzione riservata
Segui Frammenti Rivista anche su Facebook, Instagram e Spotify, e iscriviti alla nostra Newsletter
Sì, lo sappiamo. Te lo chiedono già tutti. Però è vero: anche se tu lo leggi gratis, fare un giornale online ha dei costi. Frammenti Rivista è edita da una piccola associazione culturale no profit, Il fascino degli intellettuali. Non abbiamo grandi editori alle spalle. Non abbiamo pubblicità. Per questo te lo chiediamo: se ti piace quello che facciamo, puoi iscriverti al FR Club o sostenerci con una donazione. Libera, a tua scelta. Anche solo 1 euro per noi è molto importante, per poter continuare a essere indipendenti, con la sola forza dei nostri lettori alle spalle.