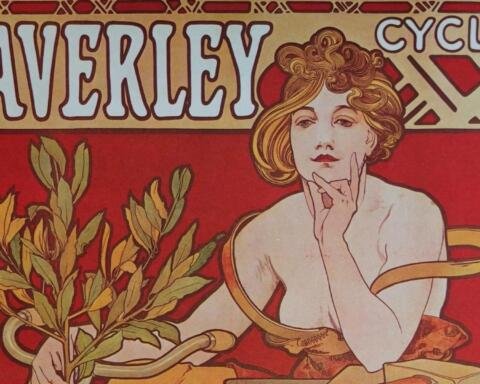Per gli amanti del genere horror c’è stato un lungo periodo di magra. Da molti anni infatti, Hollywood ci ammorba con film dell’orrore che di orrore hanno ben poco: fantasmi che infestano case/persone/oggetti, porte che sbattono, possessioni improbabili… I cliché abbondano così come anche i jump scare: rumori assordanti, facce mostruose che all’improvviso balzano verso lo spettatore cogliendolo di sorpresa e procurandogli uno (scontato) spavento. E, come non citare le classiche frasi che i protagonisti si sussurrano al calar delle tenebre? «Conosco una scorciatoia, passiamo per il cimitero», oppure «Ho sentito un rumore in cantina, vado a controllare» (da solo e al buio).
Tutti questi ingredienti riciclati hanno ormai stancato il pubblico perché rendono qualsiasi film prevedibile e noioso quasi fosse una macchina dello spavento fine a se stesso. È normale infatti che, se un demone compare all’improvviso davanti all’inquadratura, lo spettatore farà cadere i pop-corn, ma questi elementi non fanno dell’horror un horror vero e proprio. La paura è un concetto molto più profondo e intenso che si insinua in noi e ha radici ataviche. Era ora e tempo che si riscoprisse la vocazione autoriale dell’horror, quella che dà vita alle nostre peggiori paure lasciando che sia l’immaginazione dello spettatore a fare il grosso del lavoro.
Un regista che promette di essere un nuovo artista dell’horror è Robert Eggers che con il suo primo (sì, primo!) film The Witch (2015) ha convinto critica e pubblico guadagnandosi un meritato successo al botteghino.
Una famiglia puritana dei primi del ‘600, dopo essere stata bandita dal proprio villaggio, si trasferisce in una casetta vicino ad un bosco dove spera di poter vive tranquilla di agricoltura e allevamento. Presto però si rendono conto che nel bosco si celano forze maligne. Il fratellino ancora in fasce di Thomasin, la protagonista del film, scompare improvvisamente mentre la ragazza se ne sta occupando e la colpa ricade su di lei. Da quell’evento tragico ne succedo molti altri e il bigottismo, la superstizione e l’ossessione per il peccato prendono il sopravvento sulla famiglia che comincia ad accusarsi a vicenda di stregoneria.
La bellezza di questo film sta soprattutto nelle inquadrature e nella fotografia: la fioca presenza di luce infatti è studiata in modo tale da far sembrare molte scene simili ai dipinti fiamminghi.

Niente effetti speciali. Solo scene molto ben studiate in modo tale da dare allo spettatore un senso di attesa e di angoscia. A marcare queste sensazioni c’è la disturbante colonna sonora composta da Mark Korven che in qualche tratto ricorda il Requiem di Ligeti.
I personaggi stessi sono fonte di ansia: intrappolati nei loro vestiti tipici dell’epoca (sottolineatura dei tabù anche e soprattutto sessuali) danno un senso di chiusura e claustrofobia. I più grotteschi sono senza dubbio i gemellini che, sembrano dei folletti maligni.
Sono molti i richiami alla simbologia esoterica degli animali il che ci ricorda la pellicola Antichrist di Lars von Trier. La lepre, il corvo, il caprone nero (che si dice sappia parlare), hanno tutti un particolare significato e contribuisce a calare lo spettatore nel clima dell’epoca, dove la superstizione regnava sovrana e, dietro ogni elemento, anche il più innocente, poteva nascondersi il Diavolo.

Una vera e propria leggenda folcloristica, un sapiente mix di horror e storia americana che ha tutte le carte in regola per diventare un cult. Possiamo solo sperare che questo film faccia scuola per le future generazioni di registi, risvegliando un tipo di horror più profondo e autoriale, dove lo spavento e la paura sono funzionali per far riflettere sull’intima essenza dell’uomo e sul suo difficile rapporto con il mondo.