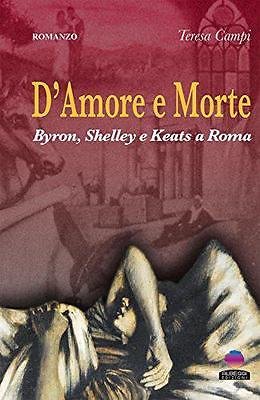Inoltrandosi nella lettura del nuovo libro di Teresa Campi, D’Amore e Morte (Albeggi Edizioni, 2016), si ha come l’impressione di essere catapultati in uno straordinario e affascinante viaggio nel tempo, un’esperienza tanto intellettuale quanto sensoriale, in grado di suscitare la percezione fisica del lettore di un mondo ormai scomparso. In una Roma ottocentesca, dove un amalgama di artisti europei confluisce come per effetto di un imbuto, giunge Christian Abrahams, giovane danese con in spalla una borsa carica di aspettative, che si accinge a scoprire quella città incantata e i suoi strabilianti personaggi.
La Campi, cimentandosi in descrizioni tanto realiste quanto suggestive, coglie perfettamente le impressioni che un qualsiasi turista, di ieri come di oggi, ha nel suo primo contatto con la città eterna: gli odori acri del cibo sugoso e ricco, la mollezza di un clima permeato da un inestinguibile sole, l’assoluta vertigine alla vista di quella magnificenza storica e artistica.
Così come la città, anche i suoi abitanti colpiscono il giovane Abrahams, che in locande e taverne incontra seducenti cameriere che servono ragù di lepre a scultori, poeti e pittori. Immersosi in questa realtà culturale, Christian, sotto consiglio dello scultore danese Thorvaldsen (il “Fidia” nordico) che si atteggia a premuroso Mecenate, inizia la sua carriera di corrispondente per riviste estere, con una predilezione tematica per la poesia, e i poeti, inglesi.
Inizia così quella che può essere definita un’avventura di crescita, di scoperta, di conoscenza, che porta non solo il protagonista, ma anche il lettore, a sbirciare nella vita dei più grandi poeti romantici il cui soggiorno a Roma fu imperniato su due comuni forze: l’amore e la morte. L’amore, l’ardore e la vitalità poetica si sviluppano, come un filo invisibile, da George Lord Gordon Byron, poeta ribelle, vanesio seduttore, esule incontentabile, a Percy Bysshe Shelley, interprete dell’invisibile, cantore metafisico e impavido, sino all’apoteosi nell’incontro velato e finale con John Keats, il ragazzo immenso, nella cui persona l’amore e la morte si fusero in una materia indistinguibile e inscindibile, lasciata come un testamento umano nei suoi irruenti versi. Il rapporto di Abrahams con ognuno di questi poeti è diverso e speciale, diretto in un caso, indiretto negli altri due, ma lascia nel suo animo ancora acerbo dei segni che lo renderanno adulto e consapevole.
La grande maestria della Campi, oltre a risiedere nel linguaggio limpido, fresco e mai pedante, sta nell’aver ricreato una storia attraverso documenti, effigi, lettere e diari, ed è proprio l’assoluta veridicità di ciò che viene letto a suscitare denso stupore ed estrema curiosità. Questo romanzo non è solo la cronaca, la scarna biografia dei grandi Romantici, ma è l’incontro privato, timido e incantato tra il lettore e i versi di costoro, è lo scambio di sentimenti, pensieri e principi che avviene nella mente di chi legge e di chi ha scritto, quel contatto così intimo e a tratti violentemente emotivo tra noi e loro. Christian Abrahams è il pubblico, è la gioventù naïve attratta irrimediabilmente dalla grandezza altrui e nella ricerca della propria.
Con una passione che emerge da ogni pagina, con la pazienza di quella che non può non essere una meticolosa ma accorata ricerca, Teresa Campi ha creato un luogo riservato e fuori dal tempo dove il lettore può trovarsi di fronte alla maestosità del passato, alla grandezza di una città immutabile, all’eternità di uomini che hanno sfiorato l’assoluto.