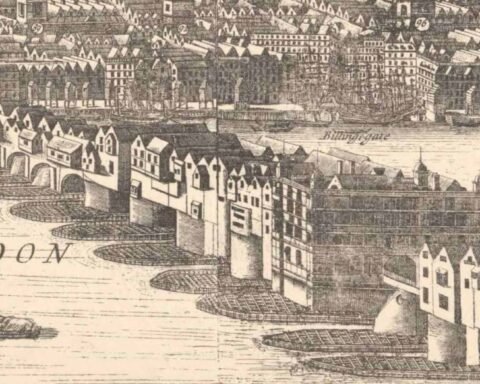Tra Franz Kafka e il cinema non c’è chissà quale grande storia d’amore. Colpa, forse, del suo stile difficile da incasellare, preciso nella scelta dei vocaboli tanto quanto enigmatico nell’ideazione delle situazioni in cui si trovano i suoi personaggi. Kafka è l’autore dell’ambiguità e del paradossale, dell’inquietudine e dell’incertezza: tra le trasposizioni più famose che hanno tentato di replicare queste sensazioni, ricordiamo Il processo del 1993, diretto da David Jones e prodotto dalla BBC; Zamok e Das Schloß, entrambi adattamenti de Il castello, uno russo del 1994 e uno austriaco del 1997; Intervista, opera meta-cinematografica di Federico Fellini uscita nel 1997, nella quale Fellini-personaggio è intento a girare un adattamento di America; infine Hans, pellicola del 2006 basata sul racconto La metamorfosi. Ma il film che più risalta per visione artistica e forza immaginifica è senz’altro Il processo del 1962, girato da Orson Welles, lo stesso regista che nel 1941, ancora enfant prodige, aveva fatto il suo esordio nella settima arte niente meno che con Quarto potere. Il processo, pur essendo uno dei film più amati da Orson Welles stesso, oggi viene spesso trascurato dalla critica, e accantonato a causa della sua cripticità. Vedremo però come, sin da subito, il regista si premuri di avvertire lo spettatore della logica non convenzionale della storia, preparandolo a un’esperienza che lambisce i confini del sogno.
Il processo – il romanzo

Pubblicato postumo nel 1925, Il processo è il primo dei tre romanzi di Franz Kafka. Redatto tra il 1914 e il 1915, in esso si rispecchia il clima di ansia e incertezza che avrebbe poi caratterizzato l’intero secolo. Il protagonista è Joseph K., un procuratore bancario che conduce un’esistenza apparentemente immacolata, finché un mattino non viene arrestato. Il suo crimine non è chiaro, e mai lo sarà, così come l’innocenza che egli professa. Determinato a opporsi alle procedure incomprensibili del tribunale che lo accusa, K. fa di tutto pur di scagionarsi: prima tentando un’arringa da sé davanti alla corte, poi rivolgendosi a un avvocato e infine a un pittore che, si dice, ha influenza sui giudici. Tuttavia, ogni sforzo è vano e, impossibilitato a difendersi – giacché ignaro fino alla fine del crimine di cui lo si accusa – K. viene giustiziato con una coltellata da due agenti del tribunale.
La critica si è lambiccata per decenni circa il significato del romanzo di Kafka. Esistono essenzialmente due macro-categorie esegetiche: la prima formata da chi reputa che la vicenda sia un sogno, e che dunque il tribunale sia un’invenzione del subconscio colpevole di K.; la seconda formata da chi, all’opposto, crede che la vicenda sia vera, con K. vittima di un regime totalitario e del suo uso improprio della legge.
Con Il processo, il lettore non è mai certo di ciò che sta leggendo. Non è sicuro che K. sia colpevole, oppure che sia innocente. Non è sicuro che il tribunale esista davvero, e nemmeno che tutte quelle apparizioni muliebri che incantano il protagonista siano reali. Non è sicuro che K. possa trionfare, oppure perdere il suo caso. Questo sentimento serpeggiante di malfidenza nei confronti degli avvenimenti della storia è dato dallo stile di Kafka, turbato e nervoso. Forse però ciò che più disorienta è proprio l’aria di quotidianità che permea il romanzo poiché, agli effetti, non c’è nulla che appartiene al mondo del fantastico – la banca, il tribunale, i palazzi, la neve, ogni singolo personaggio potrebbe davvero esistere.