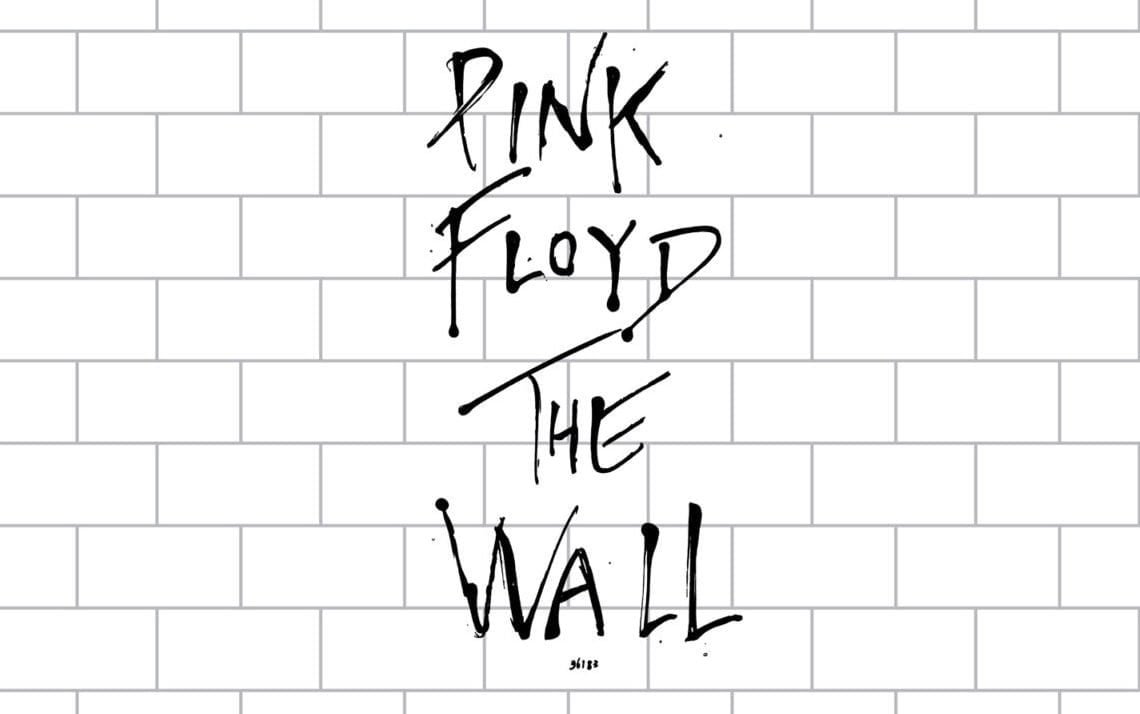L’obsolescenza programmata o pianificata, ossia la pratica delle aziende di accorciare volutamente la vita dei loro prodotti per creare nuova domanda in un tempo più breve, risale agli anni ’20 ed ebbe inizio quando un gruppo di imprese produttrici di lampadine si riunì nel cosiddetto Cartello Phoebus, per stabilire alcuni standard tecnici comuni. Tra questi venne imposta una riduzione della durata massima della vita delle lampadine, che venne portata da 2500 a 1000 ore.
L’obsolescenza programmata o pianificata, ossia la pratica delle aziende di accorciare volutamente la vita dei loro prodotti per creare nuova domanda in un tempo più breve, risale agli anni ’20 ed ebbe inizio quando un gruppo di imprese produttrici di lampadine si riunì nel cosiddetto Cartello Phoebus, per stabilire alcuni standard tecnici comuni. Tra questi venne imposta una riduzione della durata massima della vita delle lampadine, che venne portata da 2500 a 1000 ore.
La proposta del governo francese di condannare come reato l’obsolescenza programmata risale invece all’inizio di settembre 2015. La pena prevista in caso di condanna è sia di natura pecuniaria sia detentiva: multa da 300 mila euro, che può aumentare fino al 5% del fatturato aziendale nel paese e due anni di reclusione per l’amministratore delegato della società colpevole del reato. Sebbene il provvedimento presenti il problema di non specificare cosa si intenda esattamente per obsolescenza programmata, questo è comunque un passo nella direzione giusta, che va a porre l’attenzione su un problema finora molto sottovalutato, le cui conseguenze non sono in molti a conoscere.
Lo svantaggio immediatamente visibile dal consumatore è senza dubbio quello che colpisce le sue tasche nel momento in cui il prodotto che aveva acquistato (si parla soprattutto di elettrodomestici) smette di funzionare molto prima di quanto avesse preventivato. Nella maggior parte dei casi, quando ciò accade la prima reazione è quella di portare l’oggetto in questione dove lo si è acquistato, per farlo riparare. Ma è in quel momento che scatta la seconda fase del meccanismo dell’obsolescenza programmata: i pezzi di ricambio non ci sono e, anche nel caso in cui ci siano, la riparazione viene apertamente sconsigliata dai negozianti, in quanto sconveniente rispetto all’acquisto di un prodotto nuovo. La pubblicità completa poi l’opera inducendo il consumatore a cedere e comprare il prodotto nuovo, presentato come più performante, più esteticamente bello, più ecologico, insomma, migliore di quello che si aveva prima. Ed ecco che il ciclo ricomincia.
Oltre a questo problema però, ve ne sono altri più nascosti ma molto severi. In primo luogo, gli ostacoli imposti alla riparazione degli oggetti privano le economie locali di molti potenziali posti di lavoro. Come ha spiegato in un’intervista Roberto Cavallo, amministratore delegato della cooperativa ERICA ed autore del libro Meno cento chili, quella in cui viviamo oggi è un’economia lineare, in cui tutto è usa e getta, nella quale, ad esempio: «il frigorifero rotto si butta via e quasi tutto si produce lontano, fuori dalla Ue». A questa egli contrappone il modello di economia circolare, nella quale i prodotti vengono invece riparati e riutilizzati, con conseguenti vantaggi sul piano economico e dell’occupazione: «l’economia circolare, essendo capace di preparare al riuso, è quella più labour intensive, cioè quella che ha più necessità di lavoro locale per unità di prodotto. […] Se si abbinano bene riuso riparazione e riciclo, questa è tutta economia locale che cresce». In breve, riparare gli oggetti converrebbe sia ai consumatori sia a potenziali nuovi piccoli imprenditori.
 Due ulteriori fenomeni, che seppur non costituiscono una conseguenza diretta dell’obsolescenza programmata ne sono alimentati in maniera significativa, riguardano la questione dei cosiddetti “minerali di conflitto” e l’e-waste o i rifiuti elettronici. Per spiegare il primo bisogna fare un passo indietro e analizzare i componenti di cui sono costituiti gli apparecchi elettronici di consumo, come ad esempio uno smartphone. Pochi sanno che i nostri telefonini sono composti da numerosi metalli preziosi, come il rame, l’oro, il tantalio e il tungsteno. Questi ultimi tre, insieme allo stagno, provengono per la maggior parte dal Congo e sono stati soprannominati “minerali di conflitto”. Il motivo è tanto semplice quanto triste: le miniere da cui sono estratti sono controllate da gruppi criminali, i quali con i ricavi finanziano i loro armamenti, che da anni portano avanti la guerra civile nel paese, un conflitto che ad oggi conta più di 5 milioni di morti. I minatori vengono trattati come schiavi e spesso sono arruolati con la forza o non hanno altra scelta per sostenere la propria famiglia. Molti sono bambini. Una volta estratti, i minerali vengono contrabbandati negli stati vicini come il Ruanda e l’Uganda, dai quali i metalli vengono venduti alle fabbriche del sud-est asiatico che producono apparecchiature elettroniche. È innegabile che questo fenomeno non dipenda direttamente e unicamente dall’obsolescenza programmata, ma da dinamiche interne che hanno motivazioni proprie. È però utile menzionarlo per comprendere il valore di ciò che buttiamo via. Un oggetto che noi consideriamo obsoleto e inutile dopo poco tempo dal suo acquisto può in realtà essere costato la vita di qualcuno.
Due ulteriori fenomeni, che seppur non costituiscono una conseguenza diretta dell’obsolescenza programmata ne sono alimentati in maniera significativa, riguardano la questione dei cosiddetti “minerali di conflitto” e l’e-waste o i rifiuti elettronici. Per spiegare il primo bisogna fare un passo indietro e analizzare i componenti di cui sono costituiti gli apparecchi elettronici di consumo, come ad esempio uno smartphone. Pochi sanno che i nostri telefonini sono composti da numerosi metalli preziosi, come il rame, l’oro, il tantalio e il tungsteno. Questi ultimi tre, insieme allo stagno, provengono per la maggior parte dal Congo e sono stati soprannominati “minerali di conflitto”. Il motivo è tanto semplice quanto triste: le miniere da cui sono estratti sono controllate da gruppi criminali, i quali con i ricavi finanziano i loro armamenti, che da anni portano avanti la guerra civile nel paese, un conflitto che ad oggi conta più di 5 milioni di morti. I minatori vengono trattati come schiavi e spesso sono arruolati con la forza o non hanno altra scelta per sostenere la propria famiglia. Molti sono bambini. Una volta estratti, i minerali vengono contrabbandati negli stati vicini come il Ruanda e l’Uganda, dai quali i metalli vengono venduti alle fabbriche del sud-est asiatico che producono apparecchiature elettroniche. È innegabile che questo fenomeno non dipenda direttamente e unicamente dall’obsolescenza programmata, ma da dinamiche interne che hanno motivazioni proprie. È però utile menzionarlo per comprendere il valore di ciò che buttiamo via. Un oggetto che noi consideriamo obsoleto e inutile dopo poco tempo dal suo acquisto può in realtà essere costato la vita di qualcuno.
 L’ e-waste è invece un fenomeno che fa la sua apparizione alla fine del ciclo vitale di un elettrodomestico. In comune con il precedente ha però la caratteristica di andare a ricadere non sui consumatori dei beni, bensì su chi quegli oggetti non se li potrà mai permettere. Mentre i bambini italiani giocano con l’ultimo modello di smartphone di papà, alcuni loro coetanei in altre parti del mondo si trovano in una discarica di rifiuti elettronici, bruciando la plastica del vecchio telefono per recuperare il rame e gli altri metalli preziosi in esso contenuti. La combustione di questi apparecchi libera sostanze altamente nocive come il cadmio, il piombo e il mercurio che sprigionano un fumo nero e denso che provoca attacchi di tosse, vomito e mal di testa e alla lunga è causa di tumori. I numeri riguardanti l’e-waste sono da capogiro: in Italia si producono 15,6 kg di rifiuti elettronici pro capite all’anno, per un totale di circa 800 mila tonnellate annue. Di queste purtroppo solo meno di un terzo viene smaltito legalmente nei centri autorizzati. La restante parte viene spedito nelle discariche abusive di Ghana, Nigeria, India, Cina e Pakistan, solo per citarne alcune.
L’ e-waste è invece un fenomeno che fa la sua apparizione alla fine del ciclo vitale di un elettrodomestico. In comune con il precedente ha però la caratteristica di andare a ricadere non sui consumatori dei beni, bensì su chi quegli oggetti non se li potrà mai permettere. Mentre i bambini italiani giocano con l’ultimo modello di smartphone di papà, alcuni loro coetanei in altre parti del mondo si trovano in una discarica di rifiuti elettronici, bruciando la plastica del vecchio telefono per recuperare il rame e gli altri metalli preziosi in esso contenuti. La combustione di questi apparecchi libera sostanze altamente nocive come il cadmio, il piombo e il mercurio che sprigionano un fumo nero e denso che provoca attacchi di tosse, vomito e mal di testa e alla lunga è causa di tumori. I numeri riguardanti l’e-waste sono da capogiro: in Italia si producono 15,6 kg di rifiuti elettronici pro capite all’anno, per un totale di circa 800 mila tonnellate annue. Di queste purtroppo solo meno di un terzo viene smaltito legalmente nei centri autorizzati. La restante parte viene spedito nelle discariche abusive di Ghana, Nigeria, India, Cina e Pakistan, solo per citarne alcune.
Accorciare volutamente la vita degli oggetti elettronici per aumentare le proprie vendite è una strategia meschina ed egoista, una raffinata arma forgiata da coloro che hanno spinto il capitalismo oltre i limiti di sicurezza, ottenebrati dalla loro cupidigia e sedotti dal mito della crescita illimitata. Contrastare questo meccanismo sarà difficile, ma non impossibile. Anche altri paesi dell’Unione Europea come Belgio, Olanda e Finlandia infatti si stanno muovendo nella stessa direzione intrapresa dalla Francia. Per quanto riguarda il Bel Paese, una proposta simile a quella dei nostri cugini era stata avanzata da SEL il 10 settembre 2013, ma non ha avuto la stessa fortuna. In attesa di una lungimirante presa di posizione in merito del nostro governo, si può però tentare di fare qualcosa. Oltre che mettere pressione perché anche in Italia vengano adottate delle misure simili, si può imparare di nuovo a tenere da conto le cose come facevano i nostri nonni, a ripararle invece di sostituirle, a valutare se davvero sia necessario cambiare così spesso i nostri gadget tecnologici o se è solo la pubblicità che ci spinge a farlo. Gli oggetti che compriamo ci costano denaro, ma se vale la logica de “il tempo è denaro” è allora altresì vero che il denaro è tempo. E continuando a comprare beni destinati ad essere buttati, buttiamo via anche il tempo che abbiamo speso per guadagnare i soldi con cui comprarli. Cambiare rotta e puntare verso un futuro dove le cose siano sempre meno usa e getta è essenziale. Non farlo non significa solo avere meno soldi in tasca alla fine del mese ed essere circondati da oggetti destinati a trasformarsi in spazzatura nel giro di poco tempo. Vuol dire rinunciare a un tipo di economia in cui vengono valorizzati il lavoro e le competenze, soprattutto locali, e dove le materie prime vengono valorizzate, invece che sfruttate senza criterio. Vuol dire contribuire ad avvelenare il posto dove vivranno i nostri figli. Vuol dire bruciare una parte della nostra vita, insieme alle nostre cose.